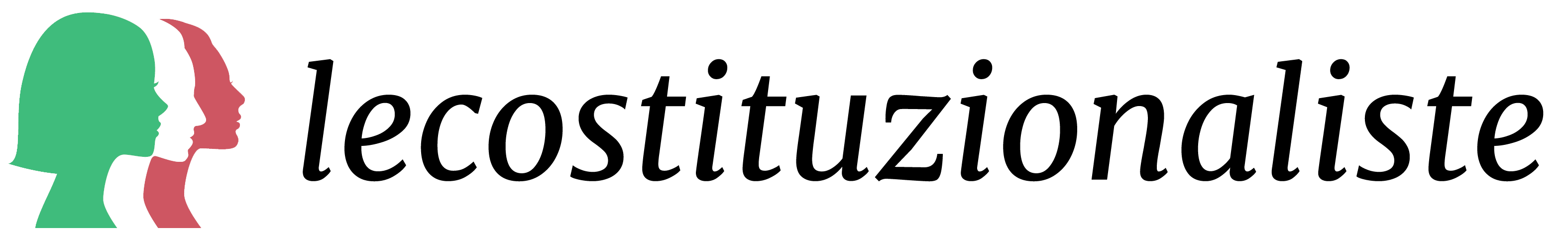di Elisa Bei*
1. Il decreto legge 11 aprile 2025, n. 48, entrato in vigore il 12 aprile 2025 e convertito, successivamente, con legge 4 giugno 2025, n. 80, (d’ora in poi decreto Sicurezza) contiene uno zoccolo duro, una sorta di core business, rappresentato da una serie di importanti modifiche in ambito penitenziario, che paiono rispondere, come meglio si avrà modo di illustrare in seguito, a una precisa logica.
In questa prospettiva, vengono immediatamente in rilievo la nuova aggravante speciale ad efficacia comune per il delitto di istigazione a disobbedire alle leggi (art. 415 c.p.), qualora venga commesso all’interno di un istituto penitenziario ovvero a mezzo di scritti o comunicazioni diretti a persone detenute e la nuova fattispecie incriminatrice di rivolta all’interno di un istituto penitenziario (art. 415 bis c.p.) il cui nucleo è rappresentato da due elementi cumulativi: la partecipazione ad una “rivolta” da parte di almeno tre persone riunite e il compimento di atti di violenza, minaccia o resistenza al compimento di atti d’ufficio o di servizio necessari per il mantenimento dell’ordine e della sicurezza nell’istituto penitenziario. Viene inoltre specificato che la resistenza può anche essere passiva quando, tenuto conto del numero delle persone coinvolte e del contesto, viene impedito il compimento di quegli atti.
Tali innovazioni acquistano una particolare luminescenza se solo si consideri il contesto nel quale esse si inseriscono: ossia la situazione nella quale si trovano attualmente gli istituti penitenziari italiani, in cui si può frequentemente assistere a episodi di proteste dato lo stato in cui questi si trovano a causa del sovraffollamento e più in generale delle pessime condizioni di vita carceraria.
Attraverso queste misure, come è stato opportunamente osservato, «si reagisce non tanto sulle cause originarie quanto sul piano repressivo, elevando l’ordine e sicurezza carceraria a valore preminente dell’istituzione penitenziaria»1.
2. In tema di esecuzione penale, un particolare focus è riservato dalla novella al regime del differimento dell’esecuzione della pena per quanto riguarda la donna incinta o la madre di prole di età inferiore a un anno2.
Invero, mentre prima del decreto Sicurezza, il rinvio dell’esecuzione della pena per la donna incinta o madre di prole di età inferiore a un anno, era disciplinato dall’art. 146 c.p., ed era, pertanto, considerato “obbligatorio”, per mezzo del decreto Sicurezza il rinvio dell’esecuzione della pena per questi stessi soggetti diviene facoltativo con lo spostamento della fattispecie della donna incinta o madre di prole di età inferiore a un anno dall’art. 146 c.p. all’art. 147 c.p.
Conseguentemente, a fronte del decreto Sicurezza, nel caso di donna incinta o madre di prole di età inferiore a un anno la sospensione dell’esecuzione della pena non è più automatica, ma il giudice di sorveglianza gode di un ampio margine di discrezionalità nel decidere se applicare o meno il beneficio alla luce delle caratteristiche del singolo caso.
La novella intervenuta in tema di donna in stato di gravidanza o madre di prole di età inferiore a un anno sembra, peraltro, non tenere in debito conto la pronuncia della Corte costituzionale n. 145 del 2009, con la quale il Giudice delle leggi aveva ritenuto manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale promosse nei riguardi dell’art. 146, comma primo, nn. 1) e 2) c.p., nella versione allora vigente, con riferimento agli artt. 3, 27, terzo comma, e 30 Cost., nella parte in cui, stabilendo il rinvio obbligatorio della pena detentiva nei confronti di donna incinta o madre di prole di età inferiore ad un anno, non prevedeva che il giudice potesse negare il differimento dell’esecuzione se lo riteneva non adeguato alle finalità di prevenzione generale e la detenzione domiciliare non era idonea a prevenire il rischio di recidiva.
In quell’occasione la Corte costituzionale aveva sottolineato come «non irragionevolmente il legislatore […] ha ritenuto, con riferimento al periodo della gravidanza e al primo anno del bambino, che la protezione del rapporto madre-figlio in un ambiente idoneo debba prevalere sull’interesse statale all’esecuzione immediata della pena. […] Inoltre, il rinvio obbligatorio del momento esecutivo non esclude che la pena irrogata possa svolgere alcuna funzione di intimidazione e dissuasione della pena e non ne vanifica pertanto il profilo retributivo-afflittivo» dato che «non ci si trova di fronte ad una rinuncia sine die della relativa esecuzione, ma solo ad un differimento per un periodo limitato». Peraltro, sempre nella pronuncia n. 145 del 2019, la Corte costituzionale aveva ricordato come il pericolo dell’utilizzazione della maternità come scudo per ottenere il rinvio fosse adeguatamente bilanciato dal fatto che il secondo comma dell’art. 146 c.p. includeva, tra le condizioni ostative alla concessione del differimento, la dichiarazione di decadenza della madre dalla potestà sul figlio e l’abbandono o l’affidamento del figlio ad altri3.
Tornando alla modifica introdotta, al fine di valutarne l’esatta portata, va rilevato che, benché il legislatore non abbia chiarito se e come vadano (ri)definiti i rapporti tra il nuovo regime del differimento dell’esecuzione della pena e l’istituto della detenzione domiciliare ex art. 47-ter co.1-ter ord. penit. (non toccato dal decreto Sicurezza), è da ritenere che anche dopo la novella in esame l’istituto della detenzione domiciliare continui a trovare applicazione nei confronti della donna incinta o madre di prole di età inferiore a un anno. Il rinvio contenuto nel ricordato co. 1-ter dell’art. 47-ter ord. penit., a tutti i casi in cui «potrebbe essere disposto il rinvio obbligatorio o facoltativo della esecuzione della pena ai sensi degli articoli 146 e 147» c.p., depone in questo senso.
Conseguentemente, benché nel caso della donna incita o madre di prole di età inferiore a un anno il rinvio dell’esecuzione della pena sia ora configurato – si è già detto – come facoltativo e non più obbligatorio, rimane, comunque, salva per il giudice, qualora non ritenga sussistano le condizioni per la concessione del rinvio, la possibilità di disporre, in alternativa alla carcerazione, la detenzione domiciliare.
Un cambiamento de jure e de facto, in questa ottica di sostanziale continuità, sembra pur doversi registrare.
Mentre prima del decreto Sicurezza, nell’ipotesi di donna incinta o madre di prole di età inferiore a un anno, la scelta a favore della detenzione domiciliare, comportando l’applicazione di una forma seppure attenuata di restrizione della libertà, finiva per rispondere a situazioni nelle quali ragioni di sicurezza non consentissero l’applicazione tout court del rinvio, oggi, invece, a seguito della novella, è ragionevole prevedere che la detenzione domiciliare verrà disposta, in alternativa alla carcerazione, dal giudice quando le esigenze di tutela del rapporto madre-figlio risultino prevalenti su quelle di sicurezza.
Al quadro sinora tracciato va aggiunto come, per mezzo dell’inserimento da parte del decreto Sicurezza, nello stesso comma primo dell’art. 147 c.p., di un nuovo numero 3-bis) – che ha recepito quanto, prima della novella, si trovava nell’art. 147, comma 1, numero 3, c.p. – continui a essere previsto, come facoltativo, il rinvio dell’esecuzione della pena per il caso di madre di prole di età compresa tra uno e tre anni.
Attraverso il nuovo comma quinto dell’art. 147 c.p., è stato poi stabilito che l’esecuzione della pena non sia comunque rinviabile ove sussista «il pericolo, di eccezionale rilevanza, di commissione di ulteriori delitti» e che, in caso di mancato differimento dell’esecuzione della pena, l’esecuzione nei confronti di madre di prole di età compresa tra uno e tre anni può avere luogo presso un istituto a custodia attenuata per detenute madri (ICAM), ove le esigenze di eccezionale rilevanza lo consentano, mentre per le donne in stato di gravidanza o madre di prole di età inferiore a un anno, l’esecuzione deve comunque avere luogo presso un istituto a custodia attenuata per detenute madri.
Pertanto, posto che il rinvio dell’esecuzione della pena risulta oggi configurato come facoltativo sia nel caso di prole di età inferiore a un anno che nel caso di madre di prole di età compresa tra uno e tre anni, va rimarcato come la più significativa differenza tra il trattamento della donna incinta o madre di prole di età inferiore a un anno e il trattamento della madre di figli di età compresa tra uno e tre anni riguardi il luogo dell’esecuzione della pena (nell’ipotesi di mancata concessione del rinvio e della detenzione domiciliare).
Mentre per le prime è contemplato un obbligo di esecuzione presso un ICAM (situazione che garantisce, quindi, seppur all’interno di un contesto carcerario, la convivenza tra madre e figlio), per le seconde il collocamento in tali istituti si avrà soltanto se quelle medesime «esigenze di eccezionale rilevanza» che hanno impedito il rinvio dell’esecuzione della pena consentono che quest’ultima sia eseguita presso un istituto a custodia attenuata.
Infine, sempre in una prospettiva carcerocentrica, alle ipotesi già vigenti di revoca del rinvio (ossia: la decadenza della madre dalla responsabilità genitoriale, la morte del figlio, l’abbandono del figlio, l’affidamento del figlio ad altri), è stata aggiunta, da parte del decreto Sicurezza, l’ipotesi per cui la madre, durante il periodo di differimento, ponga in essere comportamenti che causino un grave pregiudizio alla crescita del minore4.
Un problema destinato a trovare immediata rilevanza, già in sede di prima applicazione della novella, in assenza di una apposita disciplina transitoria, è se le disposte modifiche normative operino retroattivamente, estendendosi, quindi, anche alle persone condannate per fatti commessi prima dell’entrata in vigore del decreto Sicurezza, oppure se operino soltanto in riferimento alle persone condannate per fatti commessi dopo l’entrata in vigore del decreto Sicurezza.
Tale problema suppone la previa soluzione della questione concernente la natura giuridica, sostanziale o processuale, da riconoscere agli istituti oggetto delle operate modifiche.
Al riguardo si segnala già una prima decisione, assunta dal Magistrato di Sorveglianza di Bologna5, in sede di prima applicazione delle nuove norme, secondo la quale la disposizione di cui all’art. 147 c.p. non ha natura processuale, ma sostanziale e, pertanto, va esclusa l’operatività del principio tempus regit actum, a favore, invece, dell’applicazione del principio – di rango costituzionale – di irretroattività della sopravvenuta legge penale sfavorevole al reo.
In maniera condivisibile, il provvedimento del Magistrato di Sorveglianza di Bologna, estende alla modifica della disciplina in esame i principi contenuti nella sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 2020, con la quale la Corte costituzionale ha statuito l’applicabilità del principio di irretroattività alle modifiche normative che incidono sulla qualità e sulla quantità della pena determinando se la pena vada eseguita “fuori” dal carcere o “dentro” il carcere6 .
3. Il decreto Sicurezza ha altresì apportato modifiche a diverse disposizioni del codice di procedura penale con il palese scopo di coordinare la disciplina in materia di misure cautelari personali con quella dei nuovi articoli 146 c.p. e 147 c.p.7.
A tale proposito occorre, innanzitutto, ricordare come, ai sensi dell’art. 275, comma 4, c.p.p., la custodia cautelare in carcere non sia consentita, salvo che ricorrano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, nei confronti di donne incinte, madri di prole inferiore ai sei anni ovvero padri di prole inferiore ai sei anni, qualora la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole.
In questa prospettiva, il decreto Sicurezza ha modificato l’art. 285-bis c.p.p., che ora prevede che se la persona da sottoporre a regime detentivo è una donna incinta o una madre di prole di età inferiore ad un anno la custodia possa essere disposta esclusivamente presso un istituto a custodia attenuata.
Analogamente a quanto disposto dal già ricordato nuovo quinto comma dell’art. 147 c.p. con riguardo all’esecuzione della pena, anche per la detenzione cautelare viene, pertanto, stabilito un doppio regime in base al quale: per le donne incinte o madri di figli di età inferiore ad un anno la custodia potrà essere disposta esclusivamente presso un istituto a custodia attenuata per detenute madri (ICAM), mentre, per le madri di figli di età superiore a uno (e sino a sei) la custodia potrà essere disposta presso un ICAM solo se le esigenze cautelari di eccezionale rilevanza lo consentano.
Sempre sul versante processuale va segnalato come sia stato introdotto un nuovo art. 276-bis c.p.p. che disciplina l’ipotesi in cui detenute ospitate in istituti a custodia attenuata pongano in essere comportamenti pericolosi o tentativi di evasione prevedendo, a titolo di risposta rispetto a tali evenienze, che venga disposta la custodia in carcere della sola madre (separata, quindi, dai figli), salvo che sussistano eccezioni motivate del superiore interesse del minore, nel qual caso madre e figlio (o figli) verranno destinati a un istituto dotato del reparto attrezzato per la cura e l’assistenza necessaria.
Completano il quadro le modifiche intervenute agli artt. 386, comma 4 e 558 c.p.p. Sono state introdotte delle previsioni specifiche rivolte alle donne incinte e alle madri di bambini di età inferiore ad un anno nel momento in cui queste vengono arrestate in flagranza: si stabilisce che esse vengano messe a disposizione del pubblico ministero, in attesa della udienza di convalida avanti al giudice, tramite la conduzione presso un istituto a custodia attenuata per detenute madri, con esclusione, quindi, del carcere e degli altri luoghi di custodia diversi da esso.
Va detto come queste ultime disposizioni, analogamente a quelle intervenute in sede esecutiva, sembrano non tenere conto degli attuali limiti, in termini di capienza e collocazione geografica, degli istituti di custodia attenuata8. Il conseguente rischio è che il collocamento presso uno di essi, in ragione della distanza tra l’istituto di destinazione e il contesto familiare di provenienza della detenuta incinta o madre, si traduca in una misura comportante un surplus di afflittività con conseguente limitazione della funzione rieducativa della pena. Va inoltre ricordato come gli ICAM siano comunque delle strutture detentive e pertanto inadatte, di per sé, a ospitare bambini.
4. Volendo provare a trarre delle prime considerazioni di ordine più generale, in attesa che le novità da ultimo introdotte abbiano modo di consolidarsi all’interno del sistema, pare potersi già cogliere comunque un dato abbastanza evidente: il decreto Sicurezza, sull’onda del dilagante populismo penale, risulta espressione di una linea di politica legislativa che sembra, oggettivamente, non solo voler consolidare, ma, anzi, rafforzare una cultura carcerocentrica della pena.
Il decreto Sicurezza non è l’unico provvedimento legislativo, tra quelli più recenti, segnato da questo marchio di fabbrica, ma solo l’ultimo (per il momento). Invero, come è noto, numerose nuove fattispecie di reato, circostanze aggravanti e aggravi di pena si trovano sparsi e sparse anche, per volere fare alcuni esempi, nel decreto legge 15 settembre 2023, n. 123 convertito con modificazioni in l. 13 novembre 2023, n. 159 (c.d. decreto legge Caivano), e ancor prima, nel c.d. decreto legge 31 ottobre 2022, n. 162, convertito con modificazioni in legge 30 dicembre 2022, n. 199 (c.d. decreto legge Rave).
Ragionando sul punto, non può non tornare alla mente la sentenza Torreggiani e altri con cui la Corte Europea dei diritti umani, l’8 gennaio 2013, aveva condannato l’Italia per la violazione dell’art. 3 della Convenzione europea dei diritti umani (CEDU)9.
Il caso, allora, riguardava trattamenti inumani o degradanti subiti dai ricorrenti, sette persone detenute per molti mesi nelle carceri di Busto Arsizio e di Piacenza, in celle triple, avendo a disposizione meno di quattro metri quadrati a testa.
Come avevano affermato i giudici europei in tale occasione, «la carcerazione non fa perdere al detenuto il beneficio dei diritti sanciti dalla Convenzione. Al contrario, in alcuni casi, la persona incarcerata può avere bisogno di una maggiore tutela proprio per la vulnerabilità della sua situazione e per il fatto di trovarsi totalmente sotto la responsabilità dello Stato. In questo contesto, l’articolo 3 pone a carico delle autorità un obbligo positivo che consiste nell’assicurare che ogni prigioniero sia detenuto in condizioni compatibili con il rispetto della dignità umana, che le modalità di esecuzione della misura non sottopongano l’interessato ad uno stato di sconforto né ad una prova d’intensità che ecceda l’inevitabile livello di sofferenza inerente alla detenzione e che, tenuto conto delle esigenze pratiche della reclusione, la salute e il benessere del detenuto siano assicurati adeguatamente».
Se il tasso di sovraffollamento, allora, era quasi del 140%, oggi, a poco più di dieci anni di distanza, il dato è di nuovo pressoché lo stesso. Al 30 maggio 2025, le persone detenute risultano, infatti, 62.722 mentre i posti regolarmente disponibili ammontano a 46.706 rispetto alla capienza regolamentare di 51.285, con un tasso di sovraffollamento del 134,29%10.
Per la prima volta nella storia italiana il sovraffollamento non colpisce soltanto le carceri per adulti, ma riguarda anche gli istituti penali per minorenni (IPM) dove sono 611 i soggetti detenuti. Un record storico che ha caratteri preoccupanti se si pensa al fatto che alla fine del 2022 negli IPM c’erano 381 persone. Questo sensibile e repentino aumento delle presenze negli istituti penali per minorenni pare direttamente collegabile al c.d. decreto legge Caivano (già sopra citato), che non solo ha inasprito le pene, ma ha, rispetto ai minorenni, ampliato la possibilità di custodia cautelare e ridotto l’utilizzo delle misure alternative al carcere.
Una politica di tipo carcerocentrico non crea soltanto un problema di numeri all’interno degli istituti penitenziari, ma porta con sé, a cascata, tutta una serie di altre criticità: spazi personali ridotti, possibilità di svolgere attività ricreative o formative compromesse, e in definitiva condizioni di vita pessime o degradanti.
La conseguenza è che il carcere, così come oggi si presenta, non appare più in grado di perseguire alcuna opera di reinserimento sociale.
Peraltro, da tempo chi si occupa dei diritti delle persone detenute fa notare un collegamento tra il crescente tasso di sovraffollamento e il numero sempre più elevato di suicidi in carcere. Il 2024 è passato alla storia come l’anno con più suicidi in carcere di sempre (91).
Tra gennaio e maggio 2025, i suicidi in carcere sono già stati almeno 33.
A fronte di questa crescente sofferenza che oggi pervade gli istituti penitenziari italiani appare auspicabile che lo Stato, anziché vedere il carcere come l’unica soluzione o, comunque, la più facile, provi a implementare altre e più efficaci risposte ai bisogni e alle fragilità di chi è detenuto attraverso l’incentivazione delle pene sostitutive e l’apertura al ricorso alle misure alternative alla detenzione.
*Dottoranda di ricerca in Diritto pubblico, Giustizia penale e internazionale – Università degli Studi di Pavia
- Così F. Palazzo, Decreto sicurezza e questione carceraria, in www.sistemapenale.it, 1 maggio 2025 ↩︎
- Il primo codice di procedura penale unitario qualificava come obbligatoria la sospensione dell’esecuzione nelle ipotesi di donna incinta che fosse stata condannata a morte (art. 586 n. 1 c.p.p. 1865). Con l’entrata in vigore del codice di procedura penale del 1913 c’era stato un sostanziale ampliamento dei presupposti di operatività della sospensione dell’esecuzione, e per la prima volta assunsero dignità, in tema di sospensione dell’esecuzione della pena, le condizioni oggettive della donna incinta e della puerpera (art. 583 comma 1 n. 3 c.p.p. 1913). L’originaria formulazione dell’art. 146 c.p. contenuta nel codice Rocco contemplava l’obbligatorietà del rinvio nei confronti della donna incinta ovvero di quella che avesse partorito da meno di sei mesi. Attraverso l’art. 1 l. 8 marzo 2001, n. 40, il testo dell’art. 146 c.p. subì forti modificazioni. Oltre agli interventi meramente formali, «nei confronti di» in luogo di «contro», la tutela della maternità venne considerevolmente estesa. Invero, era venuto meno il riferimento alla «donna che [avesse] partorito da meno di sei mesi», a favore della «madre di
infante di età inferiore ad anni uno», così da garantire una maggior tutela dei bisogni del bambino, quali il completamento del ciclo di allattamento ed il conseguente svezzamento. ↩︎ - Cfr. Corte cost., 8 maggio 2009, n. 145. ↩︎
- Sul tema v. Relazione su novità normativa. Disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell’usura e di ordinamento penitenziario (d.l. 11 aprile 2025, n. 48, convertito dalla legge 9 giugno 2025, n. 80), Rel. n. 33/2025. ↩︎
- Cfr. Magistrato di Sorveglianza di Bologna, 3 giugno 2025. ↩︎
- 6 Cfr. Corte cost. 26 febbraio 2020, n. 32, a margine cfr. De Giudice A., L’irrompere del principio di irretroattività nelle vicende modificative della disciplina esecutiva, in Il Foro italiano, 2020, 3373 ss.; E. Dinacci, Esecuzione della pena e problematiche intertemporali, in Giur. it., 2020, 1773 ss.; A. Gargani, L’estensione ‘selettiva’ del principio di irretroattività alle modifiche ‘in pejus’ in materia di esecuzione della pena: profili problematici di una decisione ‘storica’, in Giur. cost., 2020, 263 ss.; A. Marsilio, Norma penale retroattiva: quando è legittima? La Consulta si pronuncia sui limiti alla retroattività della norma penale volta a modificare la natura della pena. Note a margine della sentenza del 26 febbraio 2020, n. 32 della Corte Costituzionale, in www.rivistaaic.it, 2020; F. Siracusano, L’irretroattività irrompe nella fase dell’esecuzione penale: luci e ombre di una svolta epocale, in Giur. cost., 2020, 936 ss. ↩︎
- Cfr. Relazione illustrativa al d.d.l. n. 2235, 19. ↩︎
- Cfr. C.S.M., Parere sul d.l. recante: “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica”, 30. ↩︎
- Cfr. Corte edu Torreggiani c. altri, testo integrale consultabile, a margine cfr. C. Fiorio, Torreggiani c. Italia: ultimo atto, in Antigone, 2012, 146; F. Fiorentin, Sullo stato della tutela dei diritti fondamentali all’interno delle carceri italiane, in www.dirittopenalecontemporaneo.it, 25 febbraio 2013; F. Fiorentin, Carceri italiane: tutela risarcitoria entro un anno per le vittime del sovraffollamento delle prigioni, in Guida dir., 2013, 75 ss.; F. Viganò, Sentenza pilota della Corte EDU sul sovraffollamento delle carceri italiane: il nostro Paese chiamato all’adozione di rimedi strutturali entro il termine di un anno, in www.dirittopenalecontemporaneo.it, 9 gennaio 2013; G. Della Morte, La situazione carceraria italiana viola strutturalmente gli standard sui diritti umani (a margine della sentenza Torreggiani c. Italia),
in Dir. umani dir. internaz., 2013, 147; M. Dova, Torreggiani c. Italia, un barlume di speranza nella cronaca delsistema sanzionatorio, in Riv. it. dir. proc. pen., 2013, p. 948; G. Tamburino, La sentenza Torreggiani e altri della Corte di Strasburgo, in Cass. pen., 2013, 11; C. L. Volino, La protezione diretta e indiretta dei diritti del detenuto, in www.dirittopenalecontemporaneo.it, 26 marzo 2013; P. Zicchittu, Considerazioni a margine della sentenza Torreggiani c. Italia in materia di sovraffollamento delle carceri, in Quad. cost., 2013, 161 ss.; M. Montagna, Art. 3 Cedu e sovraffollamento carcerario. La giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo ed il caso dell’Italia, in www.federalismi.it., 17 maggio 2013. ↩︎ - Cfr. Report analitico osservatorio penitenziario adulti del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale, in www.sistemapenale.it, 9 luglio 2025. ↩︎