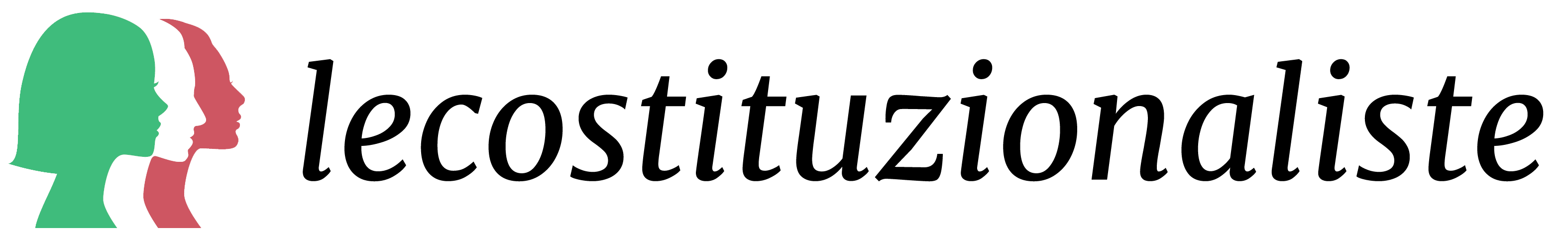Sandro Staiano*
1.La controversia, politica e giuridica, sul limite dei mandati dei Presidenti delle Giunte regionali direttamente eletti ha preso quota in sede di giurisdizione costituzionale con riferimento al caso Campania, mentre da altre Regioni si seguivano gli sviluppi della vicenda, per le ricadute generali potenziali della decisione attesa. Ora la Corte costituzionale sembra aver chiuso il discorso con la sentenza n. 64 del 2025.
Sembra. Perché, in un contesto di bassa qualità della legislazione – anche di rango costituzionale – e di segmentazione del conflitto infra- e inter-partitico, poco è come appare o come si vorrebbe far apparire, e molto rimane nel «retrobottega della democrazia» (concetto forgiato oltre quarant’anni fa, ma sempre utile), pronto a essere ripreso, presto o tardi.
2. Com’è canonico, si parta dal quadro delle competenze legislative.
La legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1, sottoponendo a revisione l’art. 122 Cost., ha ripartito tra Stato e Regioni la competenza a disciplinare il sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale nonché dei consiglieri regionali: allo Stato la fissazione con legge (legge “quadro” o “cornice”, secondo la classica denominazione) dei princìpi fondamentali, alla Regione le norme attuative o di specificazione di questi (se si vuole, le “regole”, secondo l’altrettanto classica coppia oppositiva principio/regola).
Va subito detto che tale ultima distinzione è tra le più controverse nella teoria del diritto, sicché affaticarsi in astratto intorno alla domanda se il legislatore statale, con la legge di principio, abbia o non abbia violato il campo di competenza della legge regionale, dunque l’art. 122 Cost., dando alle proprie norme il carattere di regole auto-applicative, cioè prive della «eccedenza di contenuto deontologico o assiologico» propria dei princìpi, non ha molta utilità in questa sede. Ciò che conta è la qualificazione data a queste classi di norme e l’assetto conferito ai loro rapporti dalla giurisprudenza, comune e, soprattutto, costituzionale.
Ciò premesso, va rilevato che lo Stato è intervenuto per quanto di propria competenza con la legge 2 luglio 2004, n. 165, ponendo, tra i «princìpi fondamentali concernenti il sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale, nonché dei consiglieri regionali» (art. 1), l’obbligo, a carico della legge regionale, di prevedere la «non immediata rieleggibilità allo scadere del secondo mandato consecutivo del Presidente della Giunta regionale eletto a suffragio universale e diretto, sulla base della normativa regionale in materia» (art. 2, c. 1, lett. f).
Da qui ha preso avvio una vicenda applicativa, da parte regionale, lunga e segnata da tormentate contorsioni elusive.
La Regione Campania ha approvato la sua nuova «Legge elettorale» a cinque anni di distanza dalla legge statale di principio (e non è stata tra le ultime): legge 27 marzo 2009, n. 4.
Ma questa, comparata a leggi omologhe di altre Regioni, presenta una configurazione peculiare (che trova raro riscontro: nella conformazione della legge regionale della Puglia, 9 febbraio 2005, n. 2, la quale ignora anch’essa la legge statale di principio n. 165 del 2004, pure nelle modifiche introdotte con la legge regionale 10 marzo 2015, n. 7).
Si può notare, anzitutto, che all’art. 1, cc. 2 e 3, sotto la rubrica «Princìpi», essa reca disposizioni che, secondo le regole consolidate della buona scrittura normativa, avrebbero trovato collocazione più acconcia tra le transitorie e finali. Al comma 2, per definire la disciplina dell’elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio della Regione, si fa rinvio alla legge n. 108 del 1968 e alla legge n. 43 del 1995, che disciplinavano la materia ai tempi in cui, in forza dell’originario art. 122 Cost., la determinazione del sistema elettorale regionale era affidata alla «legge della Repubblica» e il Presidente e i membri della Giunta erano eletti «dal Consiglio regionale tra i suoi componenti». Si soggiunge, nello stesso comma, che tali norme si applicano «come integrate dall’art. 5 della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1, ad eccezione delle parti incompatibili con quanto disposto negli articoli che seguono o da questi ultimi derogate».
Sul che due osservazioni.
La prima: risulta difficile comprendere come l’art. 5 della legge cost. n. 1 del 1999, in una ordinata sequenza di produzione normativa, possa integrare norme a regime, trattandosi di una norma transitoria, destinate a valere «fino alla data di entrata in vigore dei nuovi statuti regionali e delle nuove leggi elettorali ai sensi del primo comma dell’art. 122 della Costituzione», come è testualmente detto dal medesimo art. 5, cioè appunto fino all’entrata in vigore della legge regionale n. 4 del 2009 (e, prima ancora del nuovo Statuto regionale della Campania, approvato con legge regionale 28 maggio 2009, n. 6, il quale, all’art. 46, c. 1, prevede l’elezione diretta e contestuale del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale), che invece fa a sua volta richiamo a essa. Insomma, ecco un groviglio intertemporale da sciogliere con una difficile opera di interpretazione sistematica.
Seconda osservazione: il legislatore regionale dispone che le norme costituzionali poste dal richiamato art. 5 della legge cost. n. 1 del 1999 integrino le leggi ordinarie rilevanti (n. 108 del 1968 e n. 43 del 1995, si diceva), e che le norme così conformate abbiano efficacia solo se compatibili con la stessa legge regionale n. 4 del 2009, in una sorta di inusitata degradazione del rango gerarchico prodotta in forza del richiamo, e dunque della ricontestualizzazione, della norma di rango maggiore (costituzionale) ad opera della norma di rango subordinato (legislativo regionale).
Beninteso, nelle altre leggi elettorali regionali non mancano richiami alla legge n. 108 del 1968 e all’altra normazione preesistente, come è utile avvenga nei passaggi da un sistema a un altro, quando la complessità della produzione suggerisce il rinvio alla vigente legislazione compatibile (anche se la tecnica della produzione per relationem dovrebbe mantenersi entro limiti tali da rendere quanto più pervia la comprensione e quanto più univoca l’interpretazione, come non avviene abbastanza). Ma nella legge della Campania l’intero quadro normativo regionale è costruito sul corpo della legislazione statale precedente la revisione costituzionale del 1999, e – valga nuovamente notarlo – qualificando testualmente questa scelta come un «principio».
Perché un tale arzigogolo?
L’unica risposta plausibile è nella lettura sistematica della legge regionale n. 4 del 2009: questa intende collocarsi al di fuori del campo di incidenza della più volte richiamata legge statale n. 165 del 2004, che reca i princìpi fondamentali cui le leggi elettorali regionali debbono conformarsi. Infatti, la legge campana n. 4 del 2009, non solo non fa alcun richiamo espresso a tale legge (come peraltro non è necessario che avvenga, e come neppure altre omologhe leggi regionali fanno), ma non si conforma in nulla ai suoi contenuti: non vi sono norme sull’incompatibilità (art. 3, legge n. 165 del 2004); non v’è la norma sulla non immediata rieleggibilità del Presidente della Giunta regionale (art. 2, c. 1, lett. f), legge n. 165 del 2004).
In sintesi: la legge regionale della Campania n. 4 del 2009 si discosta dal modello di riparto delle competenze tra Stato e Regioni disegnato dall’art. 122 Cost., omettendo previsioni che avrebbe avuto l’obbligo di stabilire.
Tale scostamento avrebbe potuto essere qualificato come un caso di incostituzionalità. In ispecie, la omessa previsione del divieto di terzo mandato appare concepita in violazione dell’art. 122, c. 1, Cost., mediante violazione dell’art. 1, c. 2, lett. f), legge n. 165 del 2004, “norma interposta” integratrice del parametro di legittimità costituzionale (se si vuole adoperare questo modulo ricostruttivo invalso) o comunque per violazione di un vincolo costituzionale di contenuto (salvo ritenere che la norma statale, per come conformata, ecceda la propria competenza e sia essa illegittima). Come si vedrà, la sentenza della Corte costituzionale n. 64 del 2025 non lo ha fatto – cioè non ha ritenuto che andasse sanzionata l’omissione originaria – seguendo altra via per ricomporre il quadro. E, in precedenza, non v’era stata occasione per farlo, perché la legge n. 4 del 2009 era stata sottoposta al giudizio della Corte costituzionale solo con riferimento ad alcune modifiche all’art. 9, in tema di supplenza dei consiglieri regionali, con sentenza n. 118 del 2013, e sull’art. 10, concernente la rappresentanza di genere, con sent. n. 4 del 2010.
3. Essendo così configurato il quadro normativo, quando ormai si approssimava la scadenza del secondo quinquennio, era parso che il Presidente della Giunta regionale in carica potesse optare, come si evinceva da talune sue dichiarazioni, per il quieta non movere: presentare la propria candidatura per il terzo mandato sulla falsariga di quanto fatto da altri Presidenti grazie alla circostanza che le Regioni da essi governate non avevano legiferato in attuazione della legge n. 165 del 2004. In tal caso avrebbero giocato in suo favore i precedenti e una certa linea interpretativa dei rapporti tra legge statale e legge regionale in materia elettorale. Certo avrebbe dovuto mettere in conto un margine di rischio, per il dovere, incombente sugli applicatori, di interpretare conformemente a Costituzione la legge regionale n. 4 del 2009. E questa, al comma 3 dell’art. 1, pone, tra i «Princìpi», il seguente: «Si applicano … in quanto compatibili con la presente legge, le altre disposizioni statali e regionali, anche di natura regolamentare, vigenti in materia». Poiché tra tali «altre disposizioni statali» potrebbe comprendersi anche quella posta dall’art. 2, c. 1, lett. f), sulla non immediata rieleggibilità, l’Ufficio elettorale centrale regionale avrebbe potuto indursi a dichiarare inammissibile la candidatura per il terzo mandato (se il divieto di candidatura fosse stato interpretato – non implausibilmente – come una fattispecie di incandidabilità). E, se ciò non fosse stato, la candidatura avrebbe potuto essere oppugnata dagli altri competitori per la carica davanti ai giudici comuni.
Una volta optato per l’integrazione in via interpretativa della legge regionale n. 4 del 2009, sarebbe passato in secondo piano il tema della immediata applicabilità della norma contenuta nella legge statale di principio, in carenza di previsioni nella legge regionale di attuazione.
La questione è antica, ma sempre «rinnova come fa la luna».
Fin dall’esperienza meno recente, a partire dal 1970, al cospetto di una certa renitenza delle Regioni a esercitare le competenze legislative, l’orientamento dello Stato a introdurre con propria legge, accanto ai princìpi fondamentali, anche la disciplina di dettaglio, assumendone la “cedevolezza”, cioè la possibilità che se ne operi la sostituzione solo con l’effettiva produzione della diversa disciplina da parte regionale, la giurisprudenza costituzionale ha oscillato innanzi ai diversi interessi in gioco: da una parte la necessità che vi sia risposta legislativa a pressanti esigenze di regolazione disattese dalle inadempienze regionali; dall’altra, la disincentivazione dell’intervento delle Regioni derivante dalla supplenza statale, con la conseguente lesione del principio autonomistico. In quel quadro, l’applicabilità di norme di principio dotate di struttura tale da poter risultare auto-applicative poteva trovare agevolmente campo, e una certa promiscuità tra norme statali di diversa struttura, tutte immediatamente applicabili, non era destinata a suscitare rilevanti reazioni avverse.
Dopo la revisione del Titolo V della Parte II della Costituzione, il pendolo della giurisprudenza costituzionale è parso oscillare verso la preclusione della immediata applicabilità dei princìpi fondamentali, in carenza della legge regionale di attuazione, anche quando essi abbiano una struttura tanto puntuale da renderla in concreto possibile. Più di recente, la Corte costituzionale era parsa riorientarsi, ritenendo che la legge statale di principio potesse contenere, accanto a norme di principio conformate in modo tale da richiedere, per poter essere applicate, l’intermediazione della legge regionale, anche norme di principio più ravvicinate alle fattispecie regolate e norme di dettaglio, tali da poter essere auto-applicative, per le quali tale intermediazione non necessita. E ciò senza attribuire alcun rilievo all’auto-qualificazione di tali disposti come princìpi. Afferma, invero, la Corte, nella sentenza n. 70 del 2020, che la legge statale di principio può contenere «norme dalla diversa estensione sorrette da rationes distinte e infungibili, ma caratterizzate dalla comune finalità di offrire a beni non frazionabili una protezione unitaria sull’intero territorio nazionale», a prescindere dalla auto-qualificazione.
Raccogliendo la suggestione, in quella fase, si sarebbe potuto ritenere che il divieto di eccedere i due mandati rispondesse a un’esigenza di protezione del principio democratico, che impronta l’intero ordinamento e che potrebbe risultare compromesso dall’eccesso di ruolo del Presidente della Giunta, la cui elezione diretta ha già impresso una rimarchevole torsione monocratica al sistema, e la cui rieleggibilità senza limiti ne farebbe potenzialmente un incumbent di fatto invincibile nella competizione politica.
Tuttavia, ragioni di prudenza interpretativa consigliavano di non saltare immediatamente a tali conclusioni (cui è ora pervenuta la sentenza n. 64 del 2025, ma con un approccio dommatico non del tutto lineare), poiché talvolta l’orientamento della Corte, prima di consolidarsi in precedenti univoci, può essere determinato dalle specifiche connotazioni dell’ambito materiale in cui la singola decisione interviene (nella richiamata sentenza n. 70 del 2020, il riferimento è alla materia dell’edilizia, ove si è realizzata una tensione acuta tra lo Stato, in alcune fasi orientato a garantire l’integrità del territorio e dell’ambiente, e la sicurezza in aree a rischio, e talune Regioni, tendenti invece a favorire l’edificazione intensiva assecondando spinte localistiche).
Conviene, per converso, partire dalla giurisprudenza costituzionale riferita specificamente alla legislazione elettorale delle Regioni, anche perché si tratta di un ambito esterno, per quanto complementare, alla previsione generale dell’art. 117, c. 3, Cost., essendo definito, come più volte rilevato, dall’art. 122, c. 1, Cost.
Ora, le decisioni della Corte costituzionale in tema hanno affermato, in prima istanza, un principio di continuità nell’applicazione della legislazione statale, inferendone l’inapplicabilità del divieto di terzo mandato senza l’intermediazione della legge regionale: «il nuovo testo dell’art. 122 della Costituzione, come sostituito dalla legge costituzionale n. 1 del 1999 – che riserva alla Regione la competenza legislativa in materia, tra l’altro, di incompatibilità dei consiglieri regionali (con il rispetto dei limiti dei princìpi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica) – dà luogo solo a nuove e diverse possibilità di intervento legislativo della Regione» (ord. n. 383 del 2002); «in assenza di esercizio, da parte della Regione Campania, del potere legislativo riconosciuto dall’art. 122 della Costituzione, è da ritenersi vigente, in attuazione del principio di continuità …, la legislazione statale» (ord. n. 223 del 2003).
In linea con questa, risalente e piuttosto anodina, giurisprudenza costituzionale, la Corte di cassazione si è orientata, in termini generali, all’inapplicabilità diretta dei princìpi della legge n. 165 del 2004 in carenza della legge regionale elettorale di attuazione. Afferma la sent. n. 4327 del 2005: «in tanto i “princìpi fondamentali” stabiliti dalla legge n. 165 del 2004 possono avere efficacia ed essere applicabili nell’ordinamento, in quanto il legislatore regionale abbia esercitato la nuova competenza legislativa attribuitagli: è necessario, cioè, per l’applicabilità della disciplina, che nell’ordinamento siano vigenti sia la legge regionale, sia la legge statale sui “princìpi fondamentali”». E, ove la Regione non abbia adottato una propria disciplina elettorale compiuta, «deve ritenersi l’efficacia nella Regione della normativa statale preesistente … con conseguente applicabilità delle norme della legge n. 154 del 1981» (sent. n. 16218 del 2007). Identica posizione è espressa, con riferimento a una fattispecie concernente la Regione Veneto, con la sent. 16898 del 2006: « … l’art. 2 della legge 165 del 2004 non può essere applicato nella specie, essendo diretto a regolare l’attività legislativa regionale in materia di ineleggibilità e non a modificare direttamente le singole ipotesi di ineleggibilità previste dalla legge statale. Non avendo la Regione Veneto provveduto a emanare una legge regionale nella specifica materia, che potesse sostituire la disciplina statale esistente in materia di ineleggibilità, correttamente la Corte d’appello ha applicato la normativa contenuta nell’art. 2, n. 10, della legge n. 154 del 1981».
Quanto alla giurisprudenza di merito, essa ha ritenuto non direttamente applicabile il principio posto dall’art. 2, c. 1, lett. f), legge n. 165 del 2004.
Il Tribunale di Milano, ricostruendo secondo il modello della potestà legislativa concorrente la disciplina dettata dall’art. 122, c. 1, Cost., afferma che « … il legislatore statale del 2004 ha inteso fermarsi sul piano dei princìpi fondamentali, delle linee guida dettate a indirizzo e argine della legislazione regionale, trattenendosi dall’invadere un campo che la Costituzione assegna al potere normativo primario delle Regioni: ha cioè dettato una norma “di principio” che costituisce un limite alla legislazione regionale … Non è rinvenibile, nel sistema del riparto delle competenze legislative di cui alla riforma del Titolo V, una norma di chiusura o un principio generale analogo a quello che, nel rapporto tra gli stati membri e l’Unione europea, permette a determinare condizioni l’immediata applicabilità della normativa comunitaria ove self- executing … Ritiene conclusivamente il Tribunale che l’art. 2, lett. f), nonostante contenga un precetto chiaro, determinato ed univoco, non possa ritenersi norma immediatamente precettiva, avendolo il legislatore statale espressamente qualificato in termini di “principio generale” cui dovrà attenersi la futura legislazione» (Tribunale di Milano, Sez. I, sent. n. 9053/2010). Quest’orientamento trova conferma nella sentenza della Corte di Appello di Milano, n. 1404/2011: la previsione dell’art. 2, c. 1, lett. f) della legge n. 165 del 2004 «sebbene dotata di un basso livello di astrattezza, tuttavia … stabilendo la non immediata rieleggibilità dopo il secondo mandato consecutivo, non esaurisce ogni possibile aspetto concernente la disciplina della succitata causa di ineleggibilità e, in particolare, le modalità operative del predetto divieto in quanto che lascia impregiudicate alcune questioni, quale la cessazione anticipata del mandato e l’entità dell’intervallo di tempo che deve intercorrere prima che si possa essere nuovamente eletti (la norma parla di non immediata rieleggibilità), che è appunto compito della Regione disciplinare». Argomenti sovrapponibili sono stati addotti dal Tribunale di Bologna, con la sent. n. 2509/2010 e dalla locale Corte di Appello, con sent. n. 453/2011. Quest’ultima ha affermato che «non si rinviene alcuna decisione che ripeta, nel sistema interno, l’istituto noto nel diritto comunitario della norma “self executing” ovvero di immediata, da altri si dice diretta, applicazione. E ciò per il semplice motivo che o la norma statale rientra nella potestà legislativa esclusiva dello Stato, e allora è evidente che non può porre alcun problema sulla sua immediata applicabilità, al pari di qualsiasi altra norma statale nelle materie di competenza riservata, ovvero, se si tratta di potestà concorrente, l’ambito proprio di potestà statale è quello della predisposizione dei principi fondamentali che di per sé non possono dirigersi direttamente se non alle Regioni, chiamate poi a specificare il principio esercitando la propria potestà … In altre parole, il criterio dirimente non è quello della specificità della disposizione statuale, bensì quello della sua appartenenza all’una o all’altra delle potestà legislative …».
Molto si potrebbe dire del pregio teorico degli argomenti posti alla base di queste decisioni, e della loro consistenza dommatica: v’è confusione concettuale e uso letteralmente promiscuo tra i concetti di principio generale e principio fondamentale; si pretende di tracciare una linea di demarcazione tra norme “di principio”, non direttamente applicabili, e norme “di dettaglio”, o “regole” che dir si voglia, solo esse direttamente applicabili, distinzione che non esiste in natura, come la Corte costituzionale si è incaricata ampiamente di dimostrare (in ispecie con le sentt. n. 50 del 2005 e n. 237 del 2009); si adduce un fallace parallelo tra auto-applicabilità dei princìpi fondamentali e norme self-executing; si confonde tra auto-applicabilità del principio fondamentale e il grado della sua cedevolezza verso la legge regionale di applicazione; si mostra inconsapevolezza della giurisprudenza costituzionale in tema, ricca e molto articolata nel tempo.
Tutto ciò si potrebbe notare. E si potrebbe aggiungere, forse risolutivamente, che la richiamata giurisprudenza di merito si è avuta interamente prima dell’entrata in vigore delle leggi elettorali regionali, vincolate a osservare la legge n. 165 del 2004, leggi che sono state effettivamente prodotte. E perciò tutta l’enfasi che è stata posta su quella giurisprudenza dai sostenitori della possibilità di un terzo mandato finisce con l’essere mal fondata: essa si riferisce a un quadro normativo non corrispondente a quello attuale nel suo tratto essenziale, cioè nel rapporto realizzatosi di fatto tra legge statale di principio e leggi regionali.
Eppure, ciò non spiega del tutto, in sé, perché il Presidente della Giunta regionale della Campania in carica abbia rinunciato a ripresentare la propria candidatura a legislazione regionale invariata. Se lo avesse fatto, si sarebbe bensì aperta la prospettiva del contenzioso giurisdizionale, ma solo come eventualità, realizzandosi la quale, peraltro, in caso di superamento dei gravami cautelari, la forza del fatto in caso di rielezione non sarebbe stata trascurabile.
Le ragioni per le quali egli abbia rinunciato a questa via vanno ricercate nel retrobottega: nel difficile rapporto con la sua area politica di riferimento, il tema della illegittimità, e del rischio da essa derivante, può essere stato adoperato dall’interlocutore interno avverso per argomentare il diniego di dare sostegno alla nuova candidatura. Obiezione difficile da contrastare.
Ecco perché il Presidente uscente si è visto sospinto verso la via stretta della modifica della legge regionale n. 4 del 2009.
Nel seguirla, la Regione Campania ha tenuto conto delle soluzioni introdotte dalle Regioni che hanno reso possibile il terzo mandato del medesimo Presidente, coltivando l’auspicio che quanto da essa apprestato potesse reggere il campo, come costituzionalmente conforme, sulla base dei “precedenti”: il seguito prova che lo ha fatto a torto.
I “precedenti” si suddividono in due fattispecie.
La prima è quella della Regione Veneto, che ha legiferato in tema con la prima legge di attuazione della legge n. 165 del 2004, stabilendo che le norme sul divieto di terzo mandato «si applicano con riferimento ai mandati successivi alle elezioni effettuate dopo la data di entrata in vigore» della legge elettorale (Regione Veneto, 16 gennaio 2012, n. 5, art. 27, c. 2), e della Regione Piemonte, che, avendo proceduto molto tardivamente alla prima attuazione, ha analogamente stabilito che le norme sul divieto di terzo mandato si applicano «a decorrere dalla XII legislatura», cioè conteggiando i mandati a partire dalle prime elezioni successive all’entrata in vigore della legge (Regione Piemonte, 19 luglio 2023, n. 12, art. 34, c. 1).
La seconda fattispecie è quella della Regione Marche, la quale, non avendo recepito il divieto di terzo mandato in sede di prima attuazione (legge 16 dicembre 2004, n. 27), ha novellato l’originaria disciplina, e ha introdotto anch’essa una norma di diritto intertemporale, facendo decorrere il divieto dalle legislature successive a quelle di entrata in vigore della nuova legge (20 febbraio 2015, n. 5).
La Regione Campania non avrebbe potuto invocare come “precedenti” in termini i casi delle Regioni Veneto e Piemonte, ma solo quello della Regione Marche, poiché ha agito anch’essa in sede di novellazione, creando cioè artificiosamente una nuova fase di diritto intertemporale, sul presupposto che, in Campania (come nelle Marche), alla legge n. 165 del 2004 non era stata data attuazione originaria per questa parte: ove è evidente l’irragionevolezza di utilizzare un inadempimento come base giustificativa di una deroga attuale “ora per allora”.
Peraltro, nessuna delle richiamate norme, prodotte dalle Regioni Veneto, Piemonte e Marche, è stata impugnata dal Governo davanti alla Corte costituzionale, e a ragion veduta, cioè deliberando negativamente.
4. Del riferimento ai precedenti e alla «prassi seguita dal Consiglio dei ministri in punto di impugnazione delle leggi regionali», la sentenza n. 64 del 2025 si libera agevolmente assumendone l’irrilevanza, così evitando di farsi impaniare in uno dei più intensi fattori di polemica politica contingente, fatta risuonare anche in giudizio dalla difesa delle Regione Campania.
Per il resto, la finezza dell’argomentazione sorretta dalla ricostruzione del «contesto storico e normativo» – più esattamente, di una delle letture che può esserne data – viene fatta prevalere con sagacia sulle ragioni della dimostrazione giuridica.
Il fattore di maggiore debolezza dommatica della linea interpretativa seguita dalla Corte costituzionale è nella sovrapposizione del contesto ordinamentale delle Regioni a quello dei Comuni, dunque della posizione del Presidente della Giunta regionale a quella del Sindaco. Del che vi è evidenza ove la sentenza n. 64 del 2025 configura come fattispecie di ineleggibilità il divieto di terzo mandato, che invece «opera», secondo quanto afferma la stessa Corte, come causa di incandidabilità. Sennonché, soggiunge la Corte, su tale qualificazione normativa, che sposterebbe il divieto di terzo mandato fuori del campo di incidenza dell’art. 122, c. 1, Cost., prevale l’«elemento finalistico», cioè lo scopo di garantire la «pienezza della libertà di voto», evitando in particolare il condizionamento derivante da «captatio benevolentiae o metus publicae potestatis». Si tratta, in tutta evidenza, di uno slittamento concettuale, logicamente inficiato da impropria generalizzazione: andrebbe dimostrata l’identità di ratio tra i due istituti, ineleggibilità e incandidabilità, in due contesti diversi, comunale e regionale. Dimostrazione impossibile, emergendo anzi dall’analisi di contesto risultanze opposte.
Quanto all’ordinamento comunale, invero, non può neppure parlarsi propriamente di forma di governo: allo Statuto comunale, la potestà di produzione del quale è attribuita dalla legge ordinaria, è ascritta la competenza a stabilire, tra l’altro, le «norme fondamentali dell’organizzazione» e i «criteri generali in materia di organizzazione dell’ente» (art. 6, c. 2, d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267). La potestà statutaria delle Regioni ha invece fondamento costituzionale, nell’art. 123, e si esercita determinando bensì «i princìpi fondamentali di organizzazione e funzionamento», ma, si potrebbe dire soprattutto, la «forma di governo» della Regione (si è ritenuto da alcuni disutile adoperare la nozione di forma di governo nel contesto regionale, e la giurisprudenza della Corte talvolta ha attenuato il senso del ricorso alla locuzione – che peraltro compare nel testo della Costituzione proprio con riferimento alle Regioni, con la revisione del Titolo V della Parte II – mettendola tra virgolette d’enfasi, ma la sentenza n. 64 del 2025 fa ricorso a essa nella pienezza del suo significato teorico e dommatico). La «forma di governo» è data dalla relazione giuridica intercorrente tra gli organi politici fondamentali della Regione, cioè tra quelli che partecipano alla funzione di governo (Consiglio in funzione legislativa, Giunta come organo esecutivo, Presidente della Giunta), e tra gli elementi costitutivi di essa va ricompreso il sistema elettorale. Dir questo è molto diverso dall’affermare, come poco perspicuamente fa la Corte con la sent. n. 64 del 2025, che «la forma di governo e la materia elettorale costituiscono, dal punto di vista concettuale, materie dai confini molto labili … e intimamente connesse»: non v’è invero né confine, per quanto labile, né semplice connessione, per quanto intima; v’è integrazione strutturale.
Ciò stante, aver attribuito la disciplina del sistema di elezione e dei casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale nonché dei consiglieri regionali alla potestà legislativa concorrente piuttosto che a quella esclusiva delle Regioni è una singolarità derivante da una di quegli irrisolti compromessi tra componenti parlamentari variamente ispirate. E dunque, per far sì che una simile norma possa comporsi armonicamente nel sistema dei rapporti Stato-Regioni, occorre che il potere di normazione di principio dello Stato venga ritenuto di stretta interpretazione, in conformità a quella che si può identificare come la sua ratio: non dare vita a sistemi elettorali conducenti a forme di governo distanti da quelle note, ad avventurose ibridazioni potenzialmente disfunzionali (in tal senso, l’art. 4 della legge n. 165 del 2004, ma valga anche richiamare la sentenza della Corte costituzionale n. 2 del 2004, dichiarativa dell’illegittimità costituzionale di norma dello Statuto della Regione Calabria, che prevedeva una commistione inedita tra presidenzialismo e parlamentarismo), e confermare il consolidato dei casi di incompatibilità e di ineleggibilità derivanti dai conflitti di interesse e dalle capacità di condizionamento derivanti da cariche rivestite e posizioni coperte nel sistema politico-istituzionale ed economico.
Nulla a che vedere col limite dei mandati. Invero, la posizione del Presidente della Giunta regionale rieletto e rieleggibile, nel rapporto con l’elettorato, si gioca interamente all’interno della struttura della forma di governo regionale, poiché riguarda il rapporto tra questa e il circuito della rappresentanza politica incentrato sull’investitura democratica. E su questo terreno non può che operare, appunto, chi è titolare della potestà regolativa della forma di governo: la Regione, il suo Consiglio, in sede statutaria e legislativa. Non si tratta, invero, di fattori esogeni di distorsione nella captazione del consenso, com’è per le cause di ineleggibilità, ma esattamente del rapporto fisiologico di responsività tra rappresentante e rappresentato. Sarà poi il legislatore statutario ed elettorale della Regione a valutare, se, nelle specifiche condizioni politiche e ordinamentali date, si possa ritenere di limitare il numero dei mandati e in quale misura.
In realtà, la previsione dell’art. 2, lett. f) della legge n. 165 del 2004 manifesta una di quelle periodiche rimeditazioni del legislatore sulla complessiva torsione monocratica impressa all’ordinamento delle autonomie territoriali, fondata sulla perniciosa ideologia dell’efficienza realizzata per concentrazione del potere, della quale, constatate le conseguenze, si vuole introdurre qualche moderazione: ove è evidente la sproporzione, per inadeguatezza, del farmaco – la limitazione del numero dei mandati consecutivi – al cospetto della dimensione del male procurato e da curare.
Ora, attendersi dalla Corte costituzionale l’incidente di legittimità costituzionale con riferimento alla norma interposta art. 2, lett. f), legge n. 165 del 2004 sarebbe considerare fallacemente la sua giurisprudenza il cristallo polito che non è, piuttosto che l’affascinante policromia argomentativa che invece è. E, tuttavia, almeno sul presupposto che tale disposto sia comunque principio fondamentale, per quanto conformato come comando assai ravvicinato alla fattispecie, sarebbe stato possibile riconoscere alla Regione la competenza a determinare il diritto intertemporale, che pure dovrebbe residuare dalla pervasività del principio “ravvicinato”, purché ciò non si risolvesse in sostanziale elusione del divieto di terzo mandato. Poi, forse ciò non avrebbe salvato la legge della Campania dalla dichiarazione di illegittimità, in ragione della pretesa di introdurre una norma transitoria a quindici anni di distanza dalla prima attuazione dalla legge statale di principio: ne sarebbe risultata una forma di sanzione a posteriori dell’originario inadempimento. Ma sarebbe stata evitata qualche crepa nella linea argomentativa.
5. Infine, va detto del baco. Il baco è nell’aver conservato integralmente in vigore la prima proposizione del primo comma dell’art. 1, legge regionale della Campania n. 16 del 2024: «Non è immediatamente rieleggibile alla carica di Presidente della Giunta regionale chi, allo scadere del secondo mandato, ha già ricoperto ininterrottamente tale carica per due mandati consecutivi» (la giurisprudenza comune di merito, qui citata al paragrafo 3, aveva ben avvertito che sarebbe spettato alle Regioni stabilire le «modalità operative» del divieto di terzo mandato, e la norma non è stata fatta oggetto di impugnazione).
La domanda che ci si può porre è intorno a quali conseguenze si produrrebbero in ordine al conteggio dei mandati in caso di dimissioni del Presidente, dunque di interruzione della carica prima della scadenza della legislatura, se il Presidente medesimo ripresentasse poi la propria candidatura.
Per i Sindaci l’ipotesi è disciplinata dall’art. 51, c. 3, dlg. n. 267 del 2000, nel testo modificato dall’art. 3, c. 1, legge 12 aprile 2022, n. 35, secondo il quale il terzo mandato è consentito se uno dei due mandati precedenti abbia avuto durata inferiore a due anni, sei mesi e un giorno, per causa diversa dalle dimissioni volontarie.
Non essendo previsto alcunché di analogo per il Presidente della Giunta regionale, conviene tornare nel retrobottega. E qui troveremo la possibilità di consentire il terzo mandato, grazie a un accordo tra le forze della maggioranza uscente sulle dimissioni anticipate, ovvero la minaccia delle dimissioni anticipate come arma distruttiva, brandita nei confronti di quelle stesse forze dal Presidente uscente e asseritamente non rieleggibile, prospettando una nuova candidatura da esse autonoma, per negoziare le condizioni dell’esodo.
Se comunque, belli domique tra le forze della maggioranza uscente, ci si orientasse per le dimissioni e l’interruzione del mandato, sarebbe probabile un seguito giurisdizionale delle decisioni, con l’implicazione di affidare al giudice, comune e costituzionale, il compito di arbitrare il conflitto politico, come avviene in tutti i casi, assai frequenti, di cattiva qualità della legislazione.
*Professore di Diritto costituzionale presso l’Università di Napoli Federico II