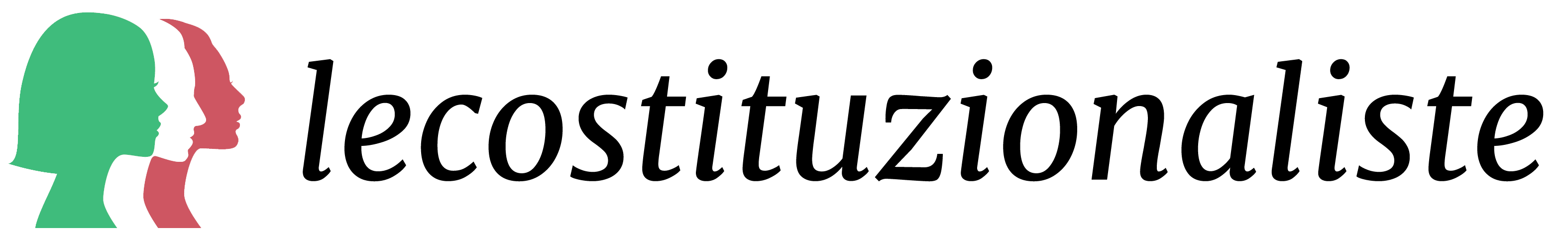Sara Di Giovanni*
Con la sentenza n. 115 del 2025, la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 27-bis del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell’articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53), come inserito dall’art. 2, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 giugno 2022, n. 105, nella parte in cui non riconosce il congedo di paternità obbligatorio anche a una lavoratrice, genitore intenzionale, nell’ambito di una coppia di donne risultanti entrambe genitori nei registri dello stato civile, per violazione dell’art. 3 Cost. – rimanendo assorbito il parametro di cui all’art. 117, primo comma, Cost.
La questione di legittimità costituzionale era stata sollevata dalla Corte d’appello di Brescia, sezione lavoro, con ordinanza del 4 dicembre 2024 (reg. ord. n. 234 del 2024), in riferimento al citato art. 27-bis, nella parte in cui riconosce il diritto al congedo di paternità obbligatorio esclusivamente al “padre lavoratore”, escludendo il secondo genitore equivalente, pur risultante nei registri dello stato civile, in contrasto con gli artt. 3 e 117, primo comma, Cost. Quest’ultimo è evocato in relazione all’art. 4 della direttiva (UE) 2019/1158 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che impone agli Stati membri di garantire il congedo di paternità anche al secondo genitore equivalente ove riconosciuto dal diritto interno.
Il giudice a quo era stato investito della cognizione, in grado di appello, di un’azione antidiscriminatoria proposta davanti al Tribunale ordinario di Bergamo da Rete Lenford – Avvocatura per i diritti LGBTI+ (da ora, Rete Lenford), che agiva a tutela delle coppie di genitori dello stesso sesso, riconosciuti tali in quanto iscritti nel registro dello stato civile.
La ricorrente, madre intenzionale nella coppia, aveva denunciato infatti la condotta antidiscriminatoria dell’Istituto nazionale della previdenza sociale (da ora, INPS), che – in conformità con la normativa vigente – aveva adottato un sistema informatico che non consentiva la presentazione telematica della domanda di congedo parentale da parte delle coppie omogenitoriali, riconosciute come tali in quanto iscritte nei registri dello stato civile.
Il giudice a quo aveva rilevato come l’art. 27-bis riservasse espressamente il congedo obbligatorio al solo “padre lavoratore”, precludendone l’accesso al secondo genitore, pur formalmente riconosciuto nei registri dello stato civile. Questa esclusione si traduceva, in concreto, nell’impossibilità per la madre intenzionale di fruire del beneficio, anche a causa della rigidità del sistema informatico dell’INPS, modellato sul dato normativo.
A sostegno della rilevanza della questione, la Corte rimettente richiamava la direttiva 2019/1158/UE, che impone agli Stati membri di estendere il diritto al congedo anche al secondo genitore equivalente. Con il d.lgs. n. 105 del 2022, il legislatore italiano dava esecuzione alla citata direttiva, prevedendo all’art. 27-bis il congedo di paternità obbligatorio con esclusivo riferimento al padre, nonostante – come sottolineava il giudice a quo – nella nostra realtà sociale e nel nostro ordinamento giuridico esistano coppie di persone dello stesso sesso riconosciute come genitori. Infatti, queste possono essere riconosciute come tali tanto da sentenze divenute esecutive, quanto dalla trascrizione dell’atto di nascita formato all’estero a seguito di tecniche di procreazione medicalmente assistita e dalla conseguente iscrizione come genitori nei registri dello stato civile, anche in seguito all’adozione in casi particolari, ex art. 44, comma 1, lett. d), della legge n. 184 del 1983: di conseguenza, risultavano formalmente esclusi dal perimetro della norma censurata.
Come conseguenza, il “secondo” genitore – riconosciuto tale – diviene titolare di un complesso di doveri (prima) e di diritti (dopo) nei confronti del minore, tra cui rientra anche il diritto al congedo parentale previsto dalla norma oggetto di censura.
Così impostata, la norma censurata violerebbe non solo la normativa sovranazionale di riferimento, ma anche il principio di eguaglianza di cui all’art. 3 Cost., in quanto due situazioni equivalenti finirebbero per essere trattate in modo diverso. Dal punto di vista dei doveri genitoriali, ai sensi degli artt. 30 e 31 Cost., infatti, sia il padre, sia la madre intenzionale sono posti sul medesimo piano. L’art. 27-bis, riconoscendo il congedo di paternità al solo padre, impedirebbe il pieno adempimento dei doveri genitoriali in capo a entrambi i genitori, indipendentemente dal genere di appartenenza.
Neppure tale problema sembrava, al giudice a quo, risolvibile tramite l’interpretazione costituzionalmente conforme, posto che il tenore letterale della norma fa esclusivo riferimento al «padre».
Costituitesi in giudizio, INPS e Avvocatura dello Stato hanno eccepito l’inammissibilità della questione, ritenendo che essa investa profili di discrezionalità legislativa. Ad avviso di entrambe, l’iscrizione nei registri dello stato civile di atti di nascita riferibili a coppie omogenitoriali non potrebbe, di per sé, comportare l’attribuzione automatica di diritti specifici, se non espressamente previsti dal legislatore. Quest’ultimo, nell’attuare la direttiva 2019/1158/UE, ha infatti limitato il congedo di paternità al solo padre, escludendo il secondo genitore equivalente.
Secondo l’INPS, l’estensione del congedo a quest’ultima figura determinerebbe una tutela potenzialmente più ampia per le coppie omogenitoriali, dando luogo a una «inammissibile discriminazione al contrario». Nelle ipotesi di adozione da parte di una coppia femminile, entrambe le madri beneficerebbero delle medesime tutele, senza che sia possibile individuare — in assenza di indicazioni normative — quale delle due ne abbia effettivo titolo.
L’Avvocatura dello Stato, infine, ha escluso che la posizione del secondo genitore possa essere equiparata a quella del padre, evidenziando come la disciplina vigente riposi su una bipartizione funzionale delle tutele genitoriali, modellata sulla famiglia “tradizionale” eterosessuale: alla madre spetterebbe l’astensione obbligatoria, al padre il congedo di dieci giorni.
La questione, in realtà, intreccia due temi importanti: quello dell’interesse superiore del minore e quello del riconoscimento della genitorialità e dei diritti (oltre che doveri) che ne conseguono, anche in capo a coppie omogenitoriali.
Tale centralità emerge chiaramente nella memoria di Rete Lenford, che richiama una importante giurisprudenza della stessa Corte costituzionale, in materia di congedi, evidenziando come tali strumenti siano volti a favorire lo sviluppo affettivo e relazionale del minore con entrambi i genitori. L’orientamento sessuale, pertanto, non può giustificare un trattamento differenziato del figlio.
Entrando nel merito della questione, il Giudice delle Leggi svolge anzitutto un approfondimento del quadro normativo di riferimento, evidenziando come le modifiche legislative intervenute nel tempo abbiano avuto come obiettivo quello di valorizzare l’eguaglianza non solo tra i coniugi e tra le varie categorie di lavoratori, ma anche tra genitorialità biologica e adottiva, nell’ottica di assicurare la migliore tutela all’interesse preminente del bambino.
Nell’ambito del riconoscimento dei diritti delle lavoratrici, la Corte rileva che le norme sui congedi e i riposi non sono state concepite esclusivamente per la tutela della donna in quanto tale, ma per garantire la protezione del primario interesse del minore.
Proprio in tale prospettiva, il legislatore ha progressivamente enucleato una disciplina volta all’estensione del trattamento di maternità anche alle ipotesi di affidamento e adozione, per giungere ai termini di una parità tra i genitori adottivi.
In tale contesto, si inserisce la questione e la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell’art. 27-bis del d.lgs n. 151 del 2001.
Di particolare rilievo appare il percorso argomentativo svolto dal Giudice delle Leggi nel dichiarare, in particolare, la violazione del principio di eguaglianza. In tale percorso emerge una diretta continuità con l’impostazione già adottata nella recente sentenza n. 68 del 2025, nella quale si era affermato il diritto del minore a vedersi riconosciute entrambe le figure genitoriali quando la coppia femminile avesse fatto ricorso alla fecondazione assistita in un Paese straniero. In entrambi i casi, il diritto delle coppie omogenitoriali non è riconosciuto “in quanto tali”, bensì attraverso la via “mediata” del best interest of the child, che si pone, dunque, come “ponte interpretativo” per il dispiegamento dello stesso principio di eguaglianza fondata – in questo caso – sull’orientamento sessuale dei genitori.
In altri termini, la Corte non basa la sua motivazione sull’individuazione dell’orientamento sessuale quale fattore autonomo di discriminazione – pur sottolineando che «l’identità di sesso non può giustificare un trattamento deteriore dei genitori» (Considerato in diritto, p.to 7.1) – quanto piuttosto il «principio di assunzione della responsabilità genitoriale». L’orientamento sessuale, dunque, non incide di per sé sull’idoneità all’assunzione di tale responsabilità, ma è l’interesse del minore a prevalere laddove impone il riconoscimento dello stato di figlio di entrambe le figure (qui, il riferimento è alla sentenza n. 68 del 2025), nonché il fascio di doveri e diritti che da tale status derivano: tra questi, anche il diritto all’accesso al congedo parentale.
In questa prospettiva, l’approccio “mediato” adottato dalla Corte non implica un’elusione totale del tema dell’orientamento sessuale, bensì una rilettura della norma alla luce della funzione che essa è chiamata a svolgere: assicurare, mediante (anche) il congedo, la protezione del minore e il rafforzamento del legame affettivo con entrambi i genitori, garantendo la possibilità, per questi ultimi, di adempiere ai propri doveri.
Dunque, la Corte non solo integra la norma, estendendone la portata anche a soggetti in posizione sostanzialmente analoga, realizzando un’effettiva eguaglianza “nella differenza”, ma insiste ancora sul modello di famiglia “tradizionale”. Ciò che giustifica l’estensione delle tutele previste anche ai genitori intenzionali, infatti, è l’assunzione di responsabilità genitoriale nei confronti del minore. In tal senso, la Corte sembra fare un ulteriore passo avanti verso il superamento del paradigma della famiglia tradizionale, fondata sul binarismo genitoriale (padre/madre), affermando piuttosto una concezione funzionale e relazionale della genitorialità, già presente nella sua giurisprudenza, ma qui strutturata in funzione dell’art. 3 Cost., anziché dell’art. 30 Cost.
In conclusione, la sentenza n. 115 del 2025 si inserisce in un percorso giurisprudenziale che – pur non riconoscendo l’orientamento sessuale quale fattore di discriminazione nella tutela delle coppie di genitori di diverso sesso – rappresenta una tappa nella “costruzione” dei diritti delle coppie omoaffettive, garantendone tutela effettiva. La Corte, tuttavia, adotta ancora una volta un approccio “mediato”, individuando nell’interesse preminente del minore il cardine e il motivo dell’estensione di tali diritti anche alle famiglia «ad instar naturae» (Corte cost., sent. n. 221 del 2019).
Ciò che emerge, dunque, non è tanto l’apertura – ormai auspicabile – al riconoscimento dell’orientamento sessuale quale fattore autonomo di discriminazione, quanto la conferma che l’assunzione della funzione genitoriale – una volta riconosciuta – impone l’accesso paritario a tutti i diritti e doveri previsti dall’ordinamento, a prescindere dall’orientamento sessuale (e non dal sesso, essendo le coppie omosessuali maschili subordinate ad una discriminazione “biologica”).
La Corte afferma così che l’eguaglianza passa attraverso la piena tutela della genitorialità in (quasi) tutte le sue forme, qualora risponda all’interesse superiore del minore.
*Dottoranda di ricerca in Diritto costituzionale – Università degli Studi di Milano Statale