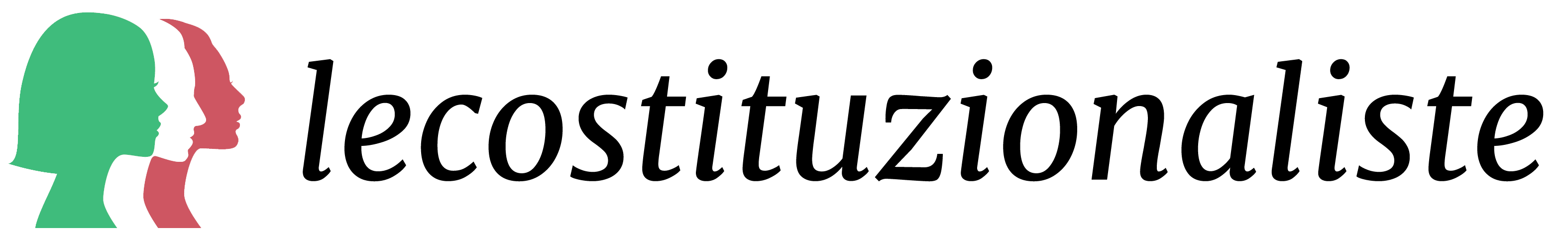di Alessandra Pioggia*
Alla domanda su cosa sia la pubblica amministrazione, non è semplice dare una risposta secca. Non è un caso che un importante manuale per studenti sia intitolato Diritto delle amministrazioni pubbliche (è quello di D. Sorace, edito per i tipi del Il Mulino e giunto alla sua undicesima edizione), a segnalare, con l’uso della sua declinazione al plurale, che è difficile comprimere al singolare la complessità e la varietà dell’amministrare la cosa pubblica. C’è però un elemento che riguarda tutte le amministrazioni e che ci consente di aggettivarle come pubbliche: il fatto di essere strumento dell’esecuzione/attuazione della legge. Ciò si traduce nella comune soggezione al principio di legalità, inteso nella sua accezione formale (nessun potere all’amministrazione senza una legge che lo preveda e lo disciplini) e sostanziale (qualsiasi azione dell’amministrazione è orientata al perseguimento della funzione ad essa attribuita dalla legge).
Ancor più sfidante è la domanda su a cosa servano le pubbliche amministrazioni.
Rispondere che il loro compito è semplicemente quello di eseguire ed attuare la legge sarebbe riduttivo e probabilmente anche sbagliato. Certamente le amministrazioni esercitano il potere a loro riconosciuto dal legislatore per compiere appieno il comando normativo, renderlo, cioè, attuale. Si tratta dei casi in cui l’autorità amministrativa produce l’effetto voluto dall’ordinamento modificando la realtà (ad esempio, trasformando con l’espropriazione il titolo di proprietà di un terreno), vigilando sulla corretta esecuzione di un comando normativo, sanzionandone la violazione, e così via. Ma l’amministrazione, anzi le amministrazioni hanno anche l’essenziale compito di rendere attuali i diritti delle persone, realizzando quel fondamentale ruolo che alla Repubblica assegna la Costituzione quando la impegna alla rimozione degli ostacoli di ordine economico e sociale che impediscono di fatto libertà e uguaglianza. Le amministrazioni prendono così la forma di ospedali, ambulatori, servizi sociali, scuole, centri di avviamento al lavoro, e altre strutture organizzate
per soddisfare bisogni fondamentali.
Mettendo insieme le due risposte che abbiamo dato, possiamo allora dire che le istituzioni amministrative eseguono il diritto per realizzare i diritti.
Questo ci porta a una terza domanda, che possiamo formulare in questi termini: eseguire il diritto è sempre sufficiente ad assicurare i diritti?
La risposta non sembra essere positiva.
Ci sono, infatti, casi in cui il diritto è correttamente eseguito, nel senso che il comando normativo è pienamente adempiuto, ma non tutti i diritti risultano assicurati. Questo è accaduto, ad esempio, con il reddito di cittadinanza, correttamente erogato a chi ne aveva fatto richiesta, ma incapace di raggiungere le persone più bisognose, quelle che, ad esempio, prive di una rete sociale di sostegno, non sapevano di averne diritto, o quelle che non erano in grado di entrare in relazione con l’amministrazione per richiederlo, per difficoltà
logistiche o linguistiche, o ancora quelle che non potevano fornire la documentazione aggiornata attestante i loro requisiti.
Ci sono poi casi in cui le norme sono rispettate, il servizio è erogato, ma altri diritti sono sacrificati. È così per la dignità delle persone costrette a giorni e notti di fila all’addiaccio per essere ricevute dagli uffici della questura per il rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno, o per le donne che, pur avendo avuto accesso al servizio di interruzione della gravidanza, sono state umiliate da parole e comportamenti di operatori e operatrici della sanità.
Infine, non mancano ipotesi in cui è la stessa applicazione del diritto a diventare ostacolo alla realizzazione dei diritti. È il caso in cui le norme, più spesso regolamentari, prevedono passaggi burocratici talmente complessi e afflittivi per le e gli utenti da rendere difficile, a volte impossibile, godere dei servizi a cui avrebbero diritto; o ancora di previsioni che, con finalità di razionalizzazione e contenimento della spesa, riducono la prossimità di alcuni servizi, di fatto impedendo alle persone con mobilità ridotta, senza un mezzo di trasporto proprio o senza il supporto di altri di accedere alle relative prestazioni.
Non sfugge il fatto che sono spesso coloro che sono più deboli e più fragili, meno attrezzati e inseriti, a veder sacrificata la realizzazione dei propri diritti dall’amministrazione.
E una amministrazione che funziona di meno per chi ne ha più bisogno tradisce il ruolo che ad essa assegna la Costituzione quando la immagina proprio come strumento per rimuovere gli ostacoli che impediscono a tutte e tutti di godere in modo eguale dei diritti che sono loro riconosciuti.
Con gli strumenti tradizionali della scienza giuridica non è facile affrontare i limiti dell’amministrazione che determinano questo effetto che ho indicato come di tradimento costituzionale. Come si evince dagli esempi fatti, non c’è violazione di legge: il comando normativo che riguarda l’attività delle amministrazioni coinvolte è sempre adempiuto puntualmente.
Come inquadrare, quindi, la questione?
Qui è utile uno sguardo diverso, anzi per usare l’aggettivazione che al soggetto femminile
riserva Carla Lonzi nel suo Sputiamo su Hegel, uno sguardo “imprevisto”, capace, cioè, di andare oltre il modo tradizionale di guardare all’amministrazione e dischiudere orizzonti alternativi. Quello che vi propongo è uno sguardo alimentato dal pensiero, anzi dai pensieri (anche qui il plurale serve a segnalare una ricchezza e varietà irriducibile ad un’etichetta singolare) femministi. La ragione per attingere a questo articolato mondo è duplice: la prima riguarda la radicalità dell’approccio critico, capace più di altri di andare alla radice, per l’appunto, delle dinamiche sociali che alimentano anche il diritto; la seconda concerne la sensibilità alla ricaduta concreta dei costrutti sociali, alle pratiche che questi generano, una sensibilità che ben si attaglia all’analisi dell’amministrazione, chiamata, per l’appunto, a mettere in pratica il comando normativo.
Per comprendere da dove vengono alcuni mali dell’amministrazione sono utili le riletture di concetti chiave dell’ordinamento come quelli di giustizia e di uguaglianza, che offrono strumenti di analisi di grande interesse. Qui faccio solo un paio di esempi.
Pensiamo alla critica femminista alla concezione di giustizia egemone nel pensiero contemporaneo occidentale, quella di matrice neo-contrattualista di cui esponente principale è John Rawls, che immagina la società giusta come esito di un processo ideale in cui si pre-decidono le regole “dietro un velo di ignoranza”. Sarebbero, cioè, buone regole quelle che i membri del patto sociale condividono, senza sapere se nella vita vera saranno poveri o ricchi, istruiti o ignoranti, dotati o meno. In questo modo i contraenti sono inevitabilmente portati a darsi regole che combinino libertà e soddisfazione dei bisogni per chi non può permettersi di farlo da solo.
Il pensiero femminista svela però come questa idea restituisca l’immagine di una società irreale: di attori isolati, maschi, adulti e autosufficienti, spinti solo dalla razionale ricerca del proprio bene individuale. Tutto questo è molto prezioso per noi, dal momento che è a partire da questa idea di società che anche l’amministrazione definisce il proprio ruolo, restituendoci nel suo modo di essere l’immagine di un apparato che funziona pienamente solo per chi rientra in quella idea di persona intorno alla quale si è costruito tutto il sistema di giustizia.
Basta pensare a come l’utente ideale, quello per il quale l’amministrazione rende al suo meglio, sia quello che conosce i propri diritti, è in grado di rivendicarli con competenza, relazionandosi efficacemente con l’amministrazione, spesso raggiungendola con un mezzo proprio, parlando bene la lingua che questa usa e potendo disporre di sé stesso e del suo tempo in modo autonomo e indipendente. È per questo che l’amministrazione, invece, funziona meno per chi dipende da altri, ma anche per chi si prende cura di persone che dipendono da sé, per chi non ha una rete di sostegno in grado di fornire una intermediazione esperta, per chi non può disporre del proprio tempo in modo indipendente, per chi non ha un mezzo proprio con cui muoversi, per chi non conosce la lingua dell’amministrazione, e così via.
Altrettanto utile è l’apparato estremamente consistente di letture critiche che i pensieri femministi hanno riservato al concetto di uguaglianza. Anche qui solo un esempio. Il pensiero patriarcale ha costruito l’uguaglianza intorno alla dimensione solo economica dei bisogni, feticizzati in forma di cose e immaginati come propri di una persona astratta e isolata dalla rete di relazioni di interdipendenza che definisce ognuna e ognuno di noi.
Questo ha spesso immiserito l’amministrazione a mera intermediaria fra mercato e utenti, la cui uguaglianza finisce per essere concepita come eguale potere di acquisto, trascurando i bisogni che non possono essere soddisfatti acquistando beni o servizi e invisibilizzando quanto ad essi necessario. È così, ad esempio, che l’assistenza domiciliare alle persone non autosufficienti è costruita come un insieme di cose e alcuni servizi, mentre la quasi totalità del sostegno che la persona necessita e che va dall’alimentazione, all’igiene, alla
mobilitazione, fino alla somministrazione dei farmaci è a carico di familiari e conviventi, spesso donne, che per questo rinunciano in tutto o in parte alla propria vita, non solo professionale.
Ma i pensieri femministi non sono utili soltanto a disvelare i limiti profondi dell’approccio amministrativo ai diritti. Offrono, infatti, strumenti di straordinario interesse anche per reimmaginare l’amministrazione in prospettiva costituzionale. Mi riferisco qui, in particolare, alla tematizzazione della “cura” come approccio etico e politico, fondato sulla consapevolezza della interdipendenza che definisce la rete di relazioni che sostiene la vita di ciascuno e ciascuna di noi. L’etica cura, come sviluppata da Carol Gilligan e poi, in una
dimensione politica, da Joan Tronto, contiene una proposta rivoluzionaria: quella di considerare la intrinseca eticità anche di un modo diverso di risolvere i dilemmi morali, affrontandoli, cioè, non impersonalmente, a partire da precetti astratti, ma interpersonalmente, attraverso una comprensione relazionale e responsabile della contingenza concreta e dei rapporti che in essa si attivano. L’etica della cura si aggiunge,
così, completandola, all’etica della giustizia. Se quest’ultima si basa sull’applicazione di regole generali e richiede un distanziamento dalla situazione concreta che intende risolvere, l’etica della cura adotta invece un approccio contestuale e narrativo, che non prescinde dalle condizioni concrete e reali su cui interviene, ma ne valorizza la specificità, generando, a partire da esse, la soluzione da applicare.
Questa dialettica fra giustizia e cura, ci rimanda al rapporto fra la legge, che deve necessariamente prendere le distanze dalla concretezza dei rapporti a cui si applica, e l’amministrare, che, nell’eseguire il diritto nella realtà, incontra invece le persone, la loro vita e l’effettività degli ostacoli che si frappongono al pieno ed eguale godimento dei diritti da parte di tutte e tutti. Diventa così possibile ricostruire in termini di etica della cura quanto dall’amministrazione è dovuto anche oltre la puntuale esecuzione della legge. L’esatto
adempimento del comando normativo è sempre necessario, ma come abbiamo visto può non essere sufficiente a realizzare i diritti. A coprire la distanza che per alcuni e alcune continua a separare il riconoscimento di un diritto dalla possibilità di goderne effettivamente è chiamata l’amministrazione, che nella sua concreta azione deve operare attivamente anche a rimuovere gli ostacoli che impediscono di ridurre e annullare quella distanza. Cosa debba fare l’amministrazione in questi casi non è però previsto in maniera puntuale, né
potrebbe esserlo, dal momento che il contenuto doveroso dell’azione deriva dalla comprensione delle condizioni specifiche, degli ostacoli reali (di fatto) che nel caso concreto impediscono di godere appieno di un diritto. Ecco, l’etica della cura è preziosa perché riconosce la natura doverosa (etica) di ciò che non può essere regolato in maniera generale ed astratta, ma sorge dalla comprensione profonda e concreta di ciò che definisce
le specifiche condizioni di bisogno.
Possiamo dire allora che l’amministrazione è tenuta ad andare oltre la legalità?
Sostenerlo non sarebbe corretto, dal momento che l’orizzonte in cui, anche oltre il comando della legge, l’amministrazione continua a muoversi è quello della legalità costituzionale. Mi piace qui ricordare una frase di Tronto che ho trovato estremamente significativa e che si può leggere nella traduzione italiana del suo Moral Boundaries del 1993: «la questione che un’etica della cura considera centrale non è cosa devo (dobbiamo) se dobbiamo qualcosa, ma come posso (possiamo) piuttosto adempiere al meglio alle mie (nostre) responsabilità
di cura».
Ecco, credo che solo una amministrazione che, dopo aver fatto “quanto deve”, non considera esaurito il proprio compito, continuando ad interrogarsi su “come può”, sia una amministrazione autenticamente costituzionale.
*Professoressa Ordinaria di Diritto Amministrativo e Pubblico presso l’Università degli Studi di
Perugia