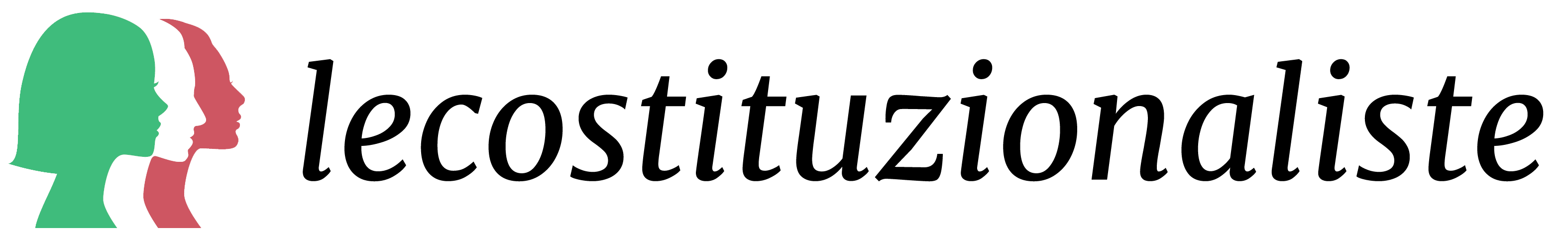*MICHELA MANETTI
1. E’ difficile aggiungere qualcosa alle penetranti censure rivolte alla costituzionalità del decreto-legge c.d. sicurezza da moltissimi giuristi, in primis da Giulio Vigevani. La mia impressione, o il mio timore, è che queste censure – per quanto indiscutibili – non siano o non saranno sufficienti a convincere la Corte, ma anche la pubblica opinione, delle illegittimità perpetrate con questo decreto. Vi invito pertanto a considerare due ulteriori argomenti, che adottano un punto di vista più ampio.
2. Il primo riguarda il metodo che come costituzionalisti intendiamo usare per interpretare la realtà. Se qualcuno ha pensato che i nuovi diritti apportino sempre progresso e maggiore libertà, dovrebbe considerare due esempi che dimostrano il contrario, entrambi radicati nella più palpitante attualità.
In tempi di populismo mediatico il diritto all’informazione, ovvero al pluralismo delle fonti notiziali, è stato, semplicisticamente, trasformato in “diritto alla verità: una risposta – della quale si è fatto giustamente molto critico Niccolò Zanon – in palese conflitto con la Costituzione, che si alimenta del dibattito e del dissenso tra diversi punti di vista. Altre sono, evidentemente, le esigenze di ordinamenti nei quali la verità storica è stata o è sistematicamente negata da un regime autoritario: esempio messo notoriamente in luce da Hannah Arendt, che viceversa riconosceva la contendibilità della “verità dei fatti” nei sistemi democratici. Ora, il diritto alla vita e alla incolumità personale, venuto in auge al tempo del terrorismo e poi della pandemia, si è trasformato – altrettanto semplicisticamente – in diritto alla sicurezza (che invece lo stesso Zanon sostiene): una pretesa alla tranquillità che lo Stato dovrebbe assicurare sino a far sparire dalla nostra mente tutti i problemi che ci assillano.
Una pretesa umanamente comprensibile, e però insaziabile, perché la sicurezza cui aspiriamo non sarà mai sufficiente. E non lo sarà perché la sensazione di pericolo che viviamo dipende dal venir meno della ben più tangibile sicurezza offerta dallo Stato sociale: offerta a noi stessi e offerta a coloro che, abbandonati al loro destino, si sono trasformati in categorie pericolose per la quiete pubblica: i disoccupati, gli sfrattati, gli emarginati, gli immigrati, e chiunque protesti contro questo stato di cose.
Dopo quarant’anni di sempre più spinta liberalizzazione dell’economia, non viviamo più nella società del rischio, come la definiva Ulrich Beck negli anni Novanta, ma nella società dell’angoscia, come s’intitola oggi un volumetto di Byung Chul Han: è così che il “diritto fondamentale alla sicurezza” diventa una parola d’ordine trascinante. Una parola d’ordine con la quale il Governo Meloni ha dapprima giustificato il decreto – legge n. 48 del 2025 davanti alla pubblica opinione, e con la quale in futuro ne potrà sostenere l’omogeneità rispetto all’art. 77 Cost., come risposta, sia pure multiforme, ad un bisogno unico ed essenziale.
Ricordo che il presidente Mattarella, in occasione di una manifestazione di studenti, quasi tutti minorenni, avvenuta a Pisa il 24 febbraio 2024 in favore del popolo palestinese, si espresse in termini molto severi, affermando che “l’autorità della polizia non si afferma con il manganello, ma con la capacità di garantire la sicurezza pur proteggendo la libertà d’espressione”.
Questo decreto è chiaramente la vendetta del governo Meloni, che autorizza l’uso del manganello tramutando i comportamenti di protesta in illeciti penali. Ma che cosa ha permesso questo cambiamento? La pervietà del discorso pubblico al tema ossessivo della sicurezza. Per fomentarlo il Governo ha previsto persino un “bonus sicurezza”, che porta con sé la detrazione fiscale per antifurti e videosorveglianza: sì che, barricati dentro casa, tenendoci in contatto solo attraverso i social, perderemo definitivamente di vista la realtà.
Ma la democrazia non può permettersi questo lusso: così come ciascuno di noi non può pretendere di mettere a tacere chi protesta, al solo fine di salvaguardare la propria spensieratezza.
3. Sotto la spinta del mutamento tecnologico e politico, la stessa Unione europea – e passo qui al secondo argomento – è arrivata velocemente alla consapevolezza che la democrazia non può reggersi, se le sue uniche fonti di informazione si riducono alle piattaforme: a ciò dobbiamo il c.d. Media Freedom Act europeo. Ma per il tema che ci occupa è direttamente rilevante un’altra normativa eurounitaria: la Direttiva (UE) 2024/1069 dell’11 aprile 2024 sulla protezione delle persone attive nella partecipazione pubblica da domande manifestamente infondate o procedimenti giudiziari abusivi («azioni legali strategiche tese a bloccare la partecipazione pubblica»)
Qui l’Unione europea segue una politica legislativa inventata da alcuni Stati americani, come la California, che da tempo proteggono il diritto all’informazione combattendo le SLAPPs (Strategic Lawsuits Against Public Participation). Tuttavia la Direttiva in esame include tra le persone attive nella partecipazione pubblica non solo i giornalisti, gli editori, le organizzazioni dei media, ma altresì i difensori dei diritti umani, le organizzazioni della società civile, le ONG, i sindacati, gli artisti, i ricercatori e gli accademici[1].
La UE vuole proteggere questi soggetti da cause giudiziarie infondate, che possono screditarli e scoraggiarli con la richiesta di indennizzi miliardari. E le vuole proteggere perché sa che determinati problemi non verrebbero mai a conoscenza della pubblica opinione se non ci fossero persone che si espongono in prima persona, ricercando le notizie, diffondendole, e manifestando nei modi più vari.
E’ facile allora capire che le stesse persone non debbono soltanto essere protette da cause giudiziarie infondate, ma anche e prima di tutto dall’incriminazione penale. In questo senso il decreto c.d. sicurezza si è posto in rotta di collisione non solo con la Costituzione, ma anche con lo spirito e la lettera della disciplina euro-unitaria.
[1] Cons. n. 6: Scopo della presente direttiva è eliminare gli ostacoli al corretto svolgimento dei procedimenti civili, proteggendo nel contempo le persone fisiche e giuridiche attive nella partecipazione pubblica su questioni di interesse pubblico, tra cui i giornalisti, gli editori, le organizzazioni dei media, gli informatori e i difensori dei diritti umani, come pure le organizzazioni della società civile, le ONG, i sindacati, gli artisti, i ricercatori e gli accademici, da procedimenti giudiziari avviati nei loro confronti per dissuaderle dalla partecipazione pubblica.
*Professoressa ordinaria di Istituzioni di Diritto Pubblico presso l’Università degli Studi di Siena