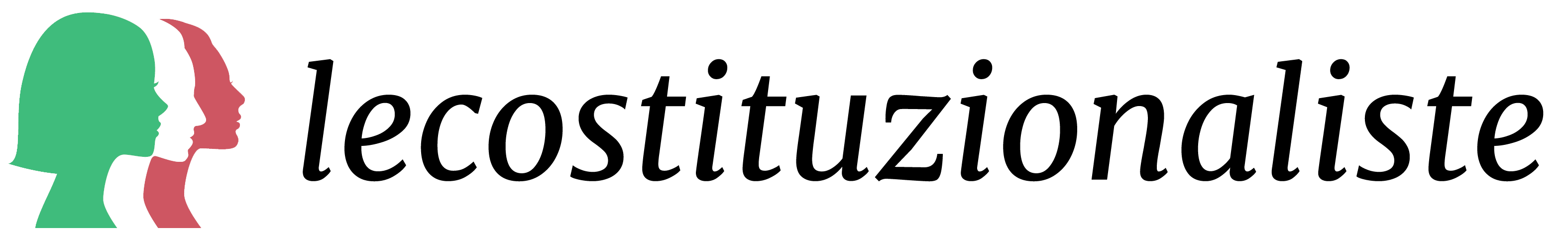*CLARA FILIBERTO
Il bilancio di genere continua ad essere, ancora oggi, uno strumento marginale e spesso trascurato nella maggior parte delle amministrazioni del nostro Paese.
Tuttavia, in un periodo storico come quello attuale, in cui più che mai è diventato impellente raggiungere gli obiettivi prefissati dall’Agenda 2030 e dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), sarebbe auspicabile volgere uno sguardo attento al bilancio di genere. Si tratta, infatti, di uno strumento potenzialmente strategico per il perseguimento della parità tra uomini e donne, grazie al quale ogni amministrazione potrebbe contribuire attivamente, secondo quanto previsto dall’articolo 3, co.2 della nostra Costituzione, a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, di fatto, limitano la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impedendone il pieno sviluppo.
Chiariamo sin da ora che, con l’espressione bilancio di genere, non si fa riferimento alla redazione di bilanci distinti per uomini e donne, quanto piuttosto all’elaborazione di un bilancio unico che tenga conto, in modo sistematico, delle differenze tra i generi nell’allocazione delle risorse e nella formulazione delle politiche pubbliche. L’obiettivo, dunque, è quello di integrare pienamente la prospettiva di genere nelle politiche di bilancio, in linea con l’approccio strategico del gender mainstreaming. Non sorprende, infatti, che le fondamenta del bilancio di genere possano rinvenirsi proprio nella Piattaforma d’azione di Pechino, adottata durante la IV Conferenza mondiale sulle donne del 1995[1], cui si attribuisce il merito di avere teorizzato questa strategia. Ed il bilancio di genere, in effetti, come è stato opportunamente evidenziato dal Consiglio d’Europa, costituisce “applicazione del principio di integrazione della dimensione di genere nella procedura di bilancio. Ciò comporta la realizzazione di una valutazione dell’impatto sul genere delle politiche di bilancio, integrando la prospettiva di genere a tutti i livelli della procedura di bilancio e riorganizzando le entrate e le uscite al fine di promuovere l’uguaglianza di genere”[2].
Secondo quanto emerge da tale definizione, il bilancio di genere si compone di due distinti strumenti: il gender auditing e il gender budgeting.
Il primo è meramente descrittivo e consente di analizzare, secondo la prospettiva di genere, le entrate e le spese di un ente pubblico valutando ex ante e monitorando ex post l’impatto che queste producono su uomini e donne: viene concepito, da un lato, come uno strumento di programmazione che può rivestire una rilevante funzione di indirizzo politico; dall’altro, come uno strumento di rendicontazione che consente di informare i cittadini sull’ammontare delle risorse destinate a promuovere la parità di genere, incrementando così la trasparenza dell’azione pubblica.
Il secondo, invece, è prettamente trasformativo, in quanto è volto alla formazione di bilanci che, mostrando una certa sensibilità verso le differenze di genere, stimolano le amministrazioni a ripensare l’uso delle risorse, riorientando i bilanci – e con essi le politiche pubbliche – verso una piena ed effettiva uguaglianza tra uomini e donne, favorendo così anche una maggiore equità, efficienza ed efficacia[3].
Si tratta, certamente, di uno strumento complesso che richiede la disponibilità di risorse economiche significative, dati disaggregati per genere, competenze specifiche all’interno delle singole amministrazioni, nonché un cambiamento politico e culturale nelle logiche di programmazione e valutazione delle politiche pubbliche. Tuttavia, pur considerando le difficoltà che le amministrazioni sono chiamate ad affrontare, non può sottacersi che il cammino verso la piena adozione e diffusione del bilancio di genere, avviato ormai da diversi anni in Italia, appare ancora eccessivamente frammentato e disomogeneo.
Ripercorrendo le origini di tale percorso, è possibile osservare che le prime esperienze di bilancio di genere sono state realizzate a livello locale, tra il 2000 e il 2001: infatti, sono stati proprio alcuni enti particolarmente virtuosi, soprattutto del Nord Italia, ad avviare, attraverso accordi amministrativi, alcune sperimentazioni aventi ad oggetto le prime forme di bilancio di genere.
Il proliferare di queste esperienze positive ha progressivamente, e attraverso un itinerario articolato e graduale, stimolato l’interesse del legislatore: prima, con alcuni disegni di legge di iniziativa parlamentare – ddl n. 3728 del 2006 e ddl n. 227 del 2006 – finalizzati all’introduzione del bilancio di genere nelle pubbliche amministrazioni che, però, non sono mai stati approvati; poi con la Direttiva del 27 luglio 2007, nota come Pollastrini-Nicolais, che ha incluso il bilancio di genere tra le misure preposte all’attuazione delle pari opportunità tra uomini e donne nelle amministrazioni pubbliche, auspicando che potesse essere promosso come prassi consolidata nelle attività di rendicontazione sociale delle amministrazioni; infine, con l’approvazione della legge n. 244 del 2007, denominata Legge finanziaria del 2008, che si è posta l’obiettivo, mai effettivamente perseguito, di introdurre il bilancio di genere per le amministrazioni statali, realizzando una sperimentazione nei Ministeri della Salute, Istruzione, Lavoro e Previdenza Sociale ed infine Università e Ricerca.
In seguito a tali iniziative, il bilancio di genere è stato finalmente introdotto con il d.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 – noto come Decreto Brunetta – volto ad ottimizzare la produttività del lavoro pubblico, nonché l’efficienza e la trasparenza delle pubbliche amministrazioni. A tal fine, gli articoli 4-10 del menzionato decreto introducono il ciclo di gestione della performance, ovvero il processo attraverso il quale le amministrazioni promuovono il proprio rendimento, creando valore pubblico e contribuendo così alla trasparenza dei processi decisionali e all’accountability.
In particolare, l’articolo 10 del decreto disciplina il Piano della performance, ovvero il documento di programmazione triennale che ogni amministrazione deve adottare e pubblicare ogni anno entro il 31 gennaio. Questo documento, che dà impulso al ciclo della performance, individua sia gli obiettivi strategico-operativi dell’amministrazione sia gli indicatori per la misurazione e la valutazione della performance in diversi ambiti, tra i quali rientra anche la parità di genere.
Oltre al Piano della performance, l’articolo 10 disciplina anche la Relazione sulla performance, ovvero quella relazione che le amministrazioni devono adottare ogni anno entro il 30 giugno, evidenziando i risultati organizzativi e individuali raggiunti nell’anno precedente e il bilancio di genere realizzato. Pertanto, non essendo incluso tra i contenuti del documento di programmazione, il bilancio di genere viene concepito dal legislatore statale esclusivamente quale strumento di rendicontazione finalizzato a valutare a posteriori l’impatto che le spese e le politiche hanno avuto sul genere. Inoltre, il legislatore non prevede alcuna sanzione nel caso in cui le amministrazioni non realizzino il bilancio di genere, né introduce una specifica metodologia per l’elaborazione dei bilanci secondo la prospettiva di genere.
Una volta operato tale intervento normativo, è stato necessario attendere fino al 2016 prima di giugnere all’approvazione di una normativa che disciplinasse in modo specifico il bilancio di genere dello Stato. Quest’ultimo, infatti, trova la sua prima base normativa nell’articolo 38-septies della legge 31 dicembre 2009, n. 196 – così come introdotto dall’articolo 9 del d.lgs. 12 maggio 2016, n. 90 – il quale prevede che il Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) avvii una sperimentazione in occasione della presentazione del Rendiconto generale dello Stato del 2016.
È con il d.p.c.m. del 16 giugno 2017, però, che viene dato un effettivo impulso a questa sperimentazione, nella misura in cui viene adottata la prima metodologia volta alla redazione del documento.
Ponendosi in linea con il Decreto Brunetta, il d.p.c.m. si preoccupa, innanzitutto, di precisare l’obiettivo che intende perseguire, ossia valutare ex post il diverso impatto che le politiche di bilancio hanno avuto su donne e uomini, in termini di denaro, servizi, tempo e lavoro non retribuito, promuovendo una maggiore trasparenza nell’allocazione delle risorse e analizzando gli effetti di tali politiche in termini di genere.
Delinea, poi, in modo specifico, la procedura da seguire per realizzare il bilancio di genere.
Ogni anno la Ragioneria Generale dello Stato adotta una circolare che, in conformità con le disposizioni del d.p.c.m., introduce apposite linee guida per consentire l’attuazione del bilancio di genere. In particolare, la circolare contiene indicazioni sulla metodologia volta a riclassificare le spese pubbliche secondo una prospettiva di genere, distinguendo tra: spese neutre; spese sensibili che producono un impatto differenziato su uomini e donne; e spese che sono finalizzate esplicitamente alla riduzione delle disuguaglianze.[4] Fornisce, inoltre, indicazioni sull’elaborazione di due questionari che le amministrazioni sono tenute a compilare – uno relativo alle politiche del personale, l’altro riferito alle politiche settoriali – al fine di comunicare le azioni svolte e le linee guida emanate per incidere sulla riduzione delle disuguaglianze di genere. Il fine è evidenziare il risultato conseguito anche attraverso l’uso di indicatori da adottare in relazione ai programmi di spesa di maggiore impatto o nell’ambito della misurazione e valutazione della performance organizzativa, in linea con i contenuti del Piano della performance e della Relazione sulla performance di cui al d.lgs. n. 150 del 2009.
Una volta ottenuta la documentazione, la Ragioneria Generale dello Stato verifica la riclassificazione delle spese e la loro coerenza con i questionari; valuta l’impatto di genere delle politiche statali attraverso l’utilizzo di indicatori statistici che coprono sia le politiche del personale dell’amministrazione sia le politiche settoriali; infine, redige il rapporto e lo trasmette al Parlamento per la pubblicazione, rendendo conto ai cittadini dell’utilizzo delle risorse pubbliche statali in termini di parità di genere.
Successivamente, con l’articolo 8 del d.lgs. 12 settembre 2018, n.116, il legislatore si è proposto di rafforzare il ruolo del bilancio di genere, valorizzando quest’ultimo come base informativa per promuovere la parità di genere attraverso le politiche pubbliche, riallocando le risorse e tenendo conto dell’andamento degli indicatori di benessere equo e sostenibile (BES) inseriti nel Documento di Economia e Finanza (DEF).
Più recentemente, anche la Strategia Nazionale per l’uguaglianza di genere 2021-2026 ha richiamato il bilancio di genere quale strumento che, offrendo un’ampia gamma di indicatori di monitoraggio, è funzionale al raggiungimento dell’obiettivi della Strategia stessa, ossia migliorare il punteggio dell’indice di parità di genere EIGE in 5 aree prioritarie: lavoro, reddito, competenze, tempo e potere.
Da ultimo, un segnale di importanza strategica si rinviene all’interno del PNRR che, individuando l’uguaglianza di genere tra le sue priorità trasversali, dà un impulso significativo al gender mainstreaming nel processo di bilancio dello Stato.
Infatti, la Milestone M1C1-110 del Piano prevede che, a partire dalla legge di bilancio per gli anni 2024-2026, il bilancio dello Stato venga riclassificato con riferimento alle spese per la promozione della parità di genere e alle spese ambientali. Per quanto riguarda specificamente il bilancio di genere, l’articolo 51-bis del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13 stabilisce che il MEF debba trasmettere al Parlamento – 30 giorni prima della presentazione del disegno di legge di bilancio – un documento informativo contenente la riclassificazione della spesa pubblica relativa alla parità di genere, in linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030, così da valutare ex ante l’impatto che le spese hanno sul genere.[5]
D’altro canto, riflessioni distinte si rendono necessarie per il bilancio di genere delle amministrazioni regionali e locali.
Se è vero che è il d.lgs. n.150 del 2009 risulta loro applicabile, è altrettanto vero che, nell’ambito di tale disciplina, non è prevista alcuna sanzione nel caso in cui le amministrazioni non adottino il bilancio di genere. Inoltre, il d.p.c.m. del 16 giugno 2017 si limita a introdurre, per le amministrazioni diverse da quelle statali (dunque, regionali e locali) la possibilità di utilizzare, su base facoltativa, la metodologia introdotta per realizzare il bilancio di genere dello Stato.
A fronte di tali considerazioni, non resta che concentrarsi sulla produzione legislativa delle diverse Regioni, dal momento che l’articolo 117, co.7 della Costituzione attribuisce proprio ai legislatori regionali la competenza in materia di parità di genere, al fine di rimuovere tutti gli ostacoli che impediscono la piena parità tra uomini e donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovere la parità di accesso alle cariche elettive.
Non può ignorarsi un dato rilevante: il quadro legislativo regionale appare estremamente frammentato e disorganico.
Infatti, seppur con una certa dose di approssimazione, è possibile osservare che, ancora oggi, molte Regioni italiane non menzionano affatto il bilancio di genere nella propria legislazione; altre, invece, ne promuovono l’adozione, sia pure in modo variegato: vi è chi si limita a identificarlo come uno strumento di rendicontazione, controllo e valutazione dell’impatto delle politiche regionali su uomini e donne[6] e chi, invece, lo introduce come uno strumento volto alla definizione delle priorità o alla riallocazione della spesa pubblica, anche collegandolo ai principi di efficacia, efficienza, trasparenza e partecipazione[7].
Nell’ambito della legislazione regionale, di particolare rilievo risulta quella dell’Emilia-Romagna, la quale prevede che, ogni anno, la Giunta debba redigere il bilancio di genere al momento della presentazione della relazione annuale, concependo quest’ultimo come strumento di rendicontazione dell’integrazione della prospettiva di genere nella pianificazione economica delle politiche pubbliche[8].
Alcune Regioni, poi, promuovono l’adozione di tale strumento anche all’interno delle amministrazioni locali che fanno parte del territorio regionale, a dimostrazione dell’importanza di una piena diffusione dello strumento de quo[9]. Nella maggior parte delle esperienze regionali, però, l’adozione del bilancio di genere da parte degli enti locali continua ad essere rimessa alla volontà politica dell’amministratore. Ed infatti sono ancora pochi i comuni che hanno deciso di introdurre il bilancio di genere nei Piani integrati di attività e organizzazione (PIAO).[10]
Quanto fin qui osservato ci consente di avanzare, in chiusura, qualche riflessione conclusiva.
Come è stato evidenziato, il nostro legislatore sembra aver compiuto, negli ultimi anni, significativi progressi con riferimento al bilancio di genere statale.
Invero, la normativa di cui all’art. 38-septies della legge 196 del 2009, così come integrata dall’art. 51-bis del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, può essere salutata con favore da molteplici punti di vista.
In primo luogo, viene superata la fase di sperimentazione che era stata avviata nel 2016, istituzionalizzando il bilancio di genere nell’ambito del Rendiconto generale dello Stato, in modo da valutare ex post, in modo sistematico e continuativo, l’impatto che le politiche di bilancio dell’anno precedente hanno avuto su uomini e donne. In secondo luogo – e questo rappresenta l’elemento di maggiore novità – propone, per la prima volta in Italia, una sperimentazione relativa al bilancio di previsione, in modo da valutare ex ante l’impatto che la spesa statale avrà sul genere, sfruttando pienamente le potenzialità del gender auditing. Infine, nonostante la permanenza di talune criticità, la normativa statale ha avuto il merito di predisporre una metodologia specifica volta a riclassificare le spese, in chiave di genere, in quattro diverse categorie, associando tale riclassificazione agli obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030.
Diverse, invece, sono le considerazioni che possono essere formulate in merito al bilancio di genere delle amministrazioni diverse da quelle statali.
Come è stato già osservato, infatti, sia il d.lgs. n. 150 del 2009, sia il d.p.c.m. del 16 giugno 2017 sono espressione di un quadro normativo complessivamente insufficiente per le amministrazioni regionali e locali, per diversi ordini di ragioni.
Innanzitutto, non vi è un obbligo di redigere il bilancio di genere che gravi su tali amministrazioni. Inoltre, la normativa di cui al d.lgs. 150 del 2009 si limita a concepire il bilancio di genere come contenuto della Relazione sulla performance, valorizzando solo parzialmente il potenziale virtuoso insito nel meccanismo del gender auditing che, se non viene integrato fin dalla fase di progettazione delle politiche pubbliche – come avviene ormai per il bilancio dello Stato – rischia di rivelarsi inefficace. Infine, manca una metodologia unica per la riclassificazione delle spese che sia paragonabile a quella che il d.p.c.m. del 16 giugno del 2017 introduce per le amministrazioni statali.
Ebbene, l’assenza di una normativa chiara, efficace ed omogena ha, di fatto, conferito alle Regioni notevoli margini di manovra, generando quel panorama legislativo disomogeneo di cui si è parlato. Ed è proprio a causa di tale disomogeneità che sembra più che mai opportuno un intervento del legislatore statale.
In proposito, merita di essere segnalata la recente presentazione, presso la Camera dei Deputati, del disegno di legge n. 3568/2022, il quale propone(va) di introdurre – a seguito di un periodo di sperimentazione – l’obbligo per tutte le amministrazioni italiane (esclusi i comuni con meno di 15.000 abitanti) di adottare il bilancio di genere, nonché di semplificare le regole metodologiche[11]. Tuttavia, l’esame di tale disegno di legge non è mai stato avviato in Parlamento per una chiara assenza di volontà politica.
Pertanto, risulta evidente che, sebbene siano stati compiuti dei passi avanti – quanto meno con riferimento al bilancio di genere dello Stato –, il cammino verso una piena ed efficace diffusione di tale strumento tra le varie amministrazioni pubbliche, quale leva per il raggiungimento dell’uguaglianza sostanziale di cui all’art. 3, co.2 della Costituzione, nonché degli obiettivi del PNRR e dell’Agenda 2030, è ancora lungo e impegnativo.
[1] Nazioni Unite, Piattaforma d’azione, Quarta Conferenza mondiale sulle donne: Azione per l’uguaglianza, lo sviluppo e la pace, Pechino, settembre 1995, paragrafi 58, lett. d), 65 lett. i), 345 e 346.
[2] Consiglio d’Europa, Gender Budgeting. Rapporto finale del Gruppo di Specialisti (EG-S-GB), Divisione per l’Uguaglianza, Direzione Generale dei Diritti Umani, Strasburgo, 2005.
[3] Si segnalano i noti studi di Anna Simonati sul tema. Si veda, per tutti, il suo ultimo contributo “Il bilancio di genere: ricostruzione e profili problematici”, in Diritto e Società, 1/2024, pp. 169–178.
[4] Per ovviare a talune criticità relative alla riclassificazione delle spese, con la circolare n. 22 del 2023 del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, è stata aggiunta una quarta categoria: le spese da approfondire, il cui impatto sul divario di genere non è noto, ma che per le loro caratteristiche potrebbero essere classificate come “sensibili”, in modo da ridurre le spese neutrali.
[5] Si veda l’Allegato-bis: “Allegati conoscitivi: bilancio di genere e bilancio ambientale” al ddl C. 2112, 23 ottobre 2024.
[6] A titolo esemplificativo, si vedano: art. 19 della Legge regionale Puglia 21 marzo 2007, n. 7; art. 1, co. 6, della Legge regionale Veneto 15 febbraio 2022, n. 3.
[7] Tra queste, si vedano: art. 8 della Legge regionale Liguria 1° agosto 2008, n. 26; art. 3 della Legge regionale Piemonte 8 marzo 2009, n. 8; art. 13 della Legge regionale Toscana 2 aprile 2009, n. 16; art. 47 della Legge regionale Umbria 25 novembre 2016, n. 14.
[8] Art. 36 della Legge regionale Emilia-Romagna 27 giugno 2014, n. 6.
[9] Art. 19 della Legge regionale Puglia 21 marzo 2007, n. 7; art. 9 della Legge regionale Liguria 1° agosto 2008, n. 26; art. 4 della Legge regionale Piemonte 18 marzo 2009, n. 8; art. 1 della Legge regionale Friuli-Venezia Giulia 16 novembre 2010, n. 20; art. 13 della Legge regionale Toscana 2 aprile 2009, n. 16; art. 47 della Legge regionale Umbria 25 novembre 2016, n. 14.
[10] Si veda, ad esempio, la Delibera della Giunta Municipale n. 308 del 2024 – Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025-2027 del Comune di Bologna.
[11]Ddl. C3568, Disposizioni in materia di redazione del bilancio di genere da parte delle regioni e degli enti locali, in www.senato.it, 21 aprile 2022.
*Dottoranda in Studi di genere presso Università degli studi di Palermo e Ciencias Jurídicas y Sociales presso Università di Málaga